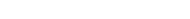Nel XVI secolo si formano gli Stati nazionali.
I monarchi cercano di capire come aumentare la ricchezza economica delle proprie nazioni e il benessere dei cittadini governati.
Colbert fece del mercantilismo una scuola amministrativa di politica economica.
I fondamenti etici e filosofici sono comuni all’assolutismo.
Il potere del monarca deriva da Dio.
E’ il monarca, su delega divina, che deve occuparsi del benessere economico della comunità politica su cui regna.
La scienza economica è la Politica economica: l’insieme delle buone condotte del monarca per il benessere economico dei suoi sudditi e del regno.
È lo Stato che fa ricchi i cittadini e il mercato lasciato a se stesso e al comportamento degli operatori non assicurerebbe da solo la ricchezza della nazione.
L’economia e il mercato sono subordinati allo Stato e agli obiettivi di politica economica che persegue.
Il mercantilismo non ebbe trattazione sistematica.
Gli scrittori mercantilisti si occuparono di problemi singoli, monetari e commerciali, e sempre da un punto di vista pratico.
I mercantilisti consigliarono divieti di esportazione della moneta e dei metalli preziosi; imposero l’obbligo ai mercanti di riportare in moneta nel paese parte almeno del prezzo ricavato all’estero; dazi all’importazione, premi all’esportazione e divieti all’uscita delle materie prime.
I mercantilisti furono protezionisti e consigliarono la creazione di grandi compagnie commerciali, l’incremento della marina mercantile, la politica colonialista, la politica demografica espansiva, la formazione di un unico mercato nazionale, la creazione di industrie di Stato.
Ne deriva una politica economica di surplus del saldo della bilancia dei pagamenti, protezionista, colonialista, con una politica demografica espansiva.
In storia si parla di neomercantilismo per il periodo a cavallo tra le due guerre.
L’attuale scontro sui dazi tra Cina e Ue conferma i concetti economici mercantili.
L’applicazione di questi principi ha però condotto sempre alla guerra tra gli Stati.
Il vero limite della politica economica mercantilista è etico: la politica economica mercantilista prepara lo Stato alla guerra contro gli altri Stati, per il predominio geopolitico ed economico.
La fisiocrazia è la Scuola economica francese, 1750-1780, il cui principale autore fu Quesnay, che elaborò la teoria del ‘sistema agricolo’ o ‘dottrina dei filosofi economisti’.
Difesa della funzione economica e degli interessi dell’agricoltura fondata su un ordine naturale preesistente e sovrastante agli ordinamenti positivi.
La scuola risente della polemica illuminista contro il potere assoluto.
Di lì a poco il contrasto tra l’emergente borghesia e la nobiltà e la Corona, sarebbe sfociato nella rivoluzione francese.
I precedenti dei fisiocrati vanno ritrovati nel giusnaturalismo e nel razionalismo illuminista.
La principale teoria fisiocratica è la teoria del prodotto netto – che dimostrerebbe la superiorità dell’agricoltura sulle altre attività umane.
Il prodotto netto è la parte del prodotto che resta disponibile dedotte le spese di produzione: è la differenza tra il grano ottenuto dal raccolto e il grano impiegato per produrlo e nutrire chi ha lavorato la terra.
Secondo i fisiocrati, l’agricoltura è l’unica vera fonte di ricchezza perché in essa la natura moltiplica il rendimento dell’opera dell’uomo.
I fisiocrati contestano il ruolo dello Stato e proclamano il fondamento naturale della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica.
La società e i proprietari fondiari vengono prima dello Stato.
Smith, al pari dei mercantilisti, fu un teorico della macroeconomia interessato alle forze che determinano la crescita economica.
È il mercato il motore dello sviluppo economico.
E’ il pensiero di Bacone e Hume a fondamento dell’analisi economica della scuola classica.
Il principio etico fondante l’economia di mercato è il principio di simpatia.
L’etica di Smith non è fondata sulla ragione, come in Aristotele, ma sui sentimenti morali, sulla simpatia che consente agli uomini di identificarsi negli altri, di comprenderne i sentimenti, l’apprezzamento e l’approvazione.
E’ questo sentimento che consente agli uomini di trovare un accordo, lo scambio, nonostante i diversi interessi ed è questo che permette la nascita del mercato.
Da questo sentimento gli individui deducono regole morali di comportamento.
La coscienza morale non è allora un principio razionale interiore ma, scaturendo dal rapporto simpatetico che l’uomo ha con gli altri, ha un carattere sociale e intersoggettivo.
In quest’ottica il diritto di proprietà non è un diritto naturale come l’intendeva Locke, né un artificio storico come sostenuto da Hume, ma il risultato di un processo speculare di simpatia e socializzante che giustifica la proprietà in quanto frutto di un lavoro personale.
Secondo Smith la ricchezza viene prodotta con il lavoro degli uomini e può essere incrementata aumentando la produttività del lavoro o il numero di lavoratori.
Il lavoro permette di determinare il “valore di scambio” di un bene.
Smith sviluppa una teoria del valore-lavoro contrapposta all’idea di una ricchezza proveniente dalla natura sostenuta dai fisiocratici.
E’ la divisione del lavoro che permette l’incremento della produttività del lavoro.
Essa consente la specializzazione, riduce il tempo necessario per passare da un’attività all’altra, la diffusione dell’utilizzo di macchine che facilitano e riducono il lavoro.
La divisione del lavoro porta i suoi benefici in termini produttivi anche quando induce la differenziazione fra mestieri e professioni.
Questo genera un'”interdipendenza sociale” e presuppone lo “scambio” e il “mercato”, con cui un individuo cede beni da lui prodotti in sovrappiù rispetto ai propri bisogni per acquisire prodotti realizzati da altri e necessari per soddisfare gli altri bisogni.
La divisione del lavoro comporta anche “conseguenze negative”: la specializzazione verso un’unica attività e la realizzazione di operazioni semplici, ripetitive e meccaniche, non sviluppa l’immaginazione e riduce le capacità intellettuali dell’individuo.
Per compensare la riduzione umana che la specializzazione comporta, Smith sostiene lo sviluppo dell’istruzione finanziata dallo Stato.
La divisione del lavoro è incrementata dall’estensione del mercato con lo sviluppo di infrastrutture di trasporto estendendo il commercio estero.
La divisione del lavoro dipende dal “livello di risparmio”.
Smith introduce la distinzione fra “valore d’uso” e “valore di scambio”: Smith considera l’utilità di un bene oggettiva, a differenza di quanto riterranno i marginalisti; altra cosa è il valore che il possesso di un oggetto conferisce nell’acquisire altri beni.
Il “prezzo di mercato” di un prodotto dipende dal confronto fra la domanda e l’offerta dello stesso e tende a convergere verso il prezzo reale.
Il prezzo di mercato gravita attorno al prezzo reale a seguito delle fluttuazioni della domanda e dell’offerta: il prezzo di mercato sarà superiore al prezzo reale se domanda>offerta, mentre sarà inferiore se offerta>domanda.
Il prezzo di mercato in ogni caso non può distanziarsi durevolmente dal prezzo reale in quanto gli operatori aggiustano l’offerta allineandola alla domanda.
Solo risorse rare e monopoli legali permettono al prezzo di mercato di distanziarsi costantemente dal prezzo reale.
Il tasso medio di profitto è il tasso d’interesse medio sulla moneta, perché il tasso d’interesse è un fenomeno reale: il “prezzo” che mette in equilibrio il capitale finanziario (risparmio) e il capitale reale (investimenti).
Il libero funzionamento di un mercato concorrenziale tende far convergere il prezzo di mercato al livello del prezzo reale e a fare scomparire qualsiasi domanda o offerta eccedentaria e a creare un ordine morale giusto.
Dall’idea che i mercati si auto regolamentano e decretano un ordine sociale giusto discendono i cardini della politica economica liberista: libero scambio (lo Stato non deve occuparsi del saldo della bilancia dei pagamenti, non deve regolare la moneta; il commercio internazionale e tutti i mercati si regolano autonomamente, la soppressione di freni al commercio interno ed esterno favorisce la divisione del lavoro e aumenta la produzione economica e il benessere collettivo) e laissez-faire (siccome i mercati si regolamentano da soli, lo Stato deve limitarsi a poche attività: difendere la Nazione da aggressioni straniere, erogare la Giustizia, occuparsi dell’Ordine Pubblico, avere rappresentanze diplomatiche presso altri Stati, costruire le infrastrutture pubbliche che consentano il commercio).
Per il resto lo Stato non deve intervenire in politica perché il mercato da solo creerà il benessere sociale e genererà lo sviluppo naturale dei commerci e delle industrie.
Smith critica i capisaldi della politica economica mercantilista: il protezionismo e l’intervento dello Stato in economia.
Smith insieme a Malthus, Say e Ricardo rappresenterà la scuola classica inglese.
Malthus, con il concetto di domanda effettiva che verrà ripreso da Keynes, elabora la teoria per cui la popolazione tende naturalmente a crescere più dei raccolti e dei mezzi di sussistenza e propone il controllo delle nascite sulla base dell’astensione dai rapporti sessuali.
Say elabora la teoria degli sbocchi: siccome i prodotti si scambiano con altri, non è possibile la sovrapproduzione e la disoccupazione.
A Ricardo si deve la Teoria dei vantaggi comparati, secondo cui esiste un vantaggio nel commercio internazionale tra due paesi se questi hanno costi comparati diversi.
Ciascun Paese si specializzerà nella produzione del bene in cui ha il minor costo comparato e importerà il bene in cui ha il maggior costo comparato.
Quindi: controllo delle nascite; liberismo (mercati si regolano da soli) e lo Stato deve rimanere inattivo; politica di libero scambio e lotta ai dazi e al protezionismo.
Verso metà XIX secolo si sviluppò la scuola storica in Germania.
List, Roscher e Knies negano la possibilità di studiare la scienza economica come una scienza naturale e ritengono che l’influenza della storia sia predominante.
E’ possibile studiare l’economia solo in un certo Paese e in una certa epoca.
Non può esistere una scienza economica, solo la storia economica.
Nel 1865 veniva data alle stampe l’opera dove List si contrappose alla teoria dei valori la teoria delle forze produttive.
Secondo List il potere di creare delle ricchezze, cioè la capacità intellettuale di organizzare le conoscenze d’ingegneria, di tecnica economica e giuridica in una struttura atta a cooperare con le altre famiglie, è cosa diversa e più importante della ricchezza in sé.
La capacità di produrre ricchezza non dipende solo dalle leggi del mercato ma anche dall’intelligenza e dall’abilità con le quali il lavoro è utilizzato.
La moderna teoria economica ha riscoperto questa verità laddove ha saputo riconoscere nella continua innovazione tecnologica, nel “know-how”, nella differenziazione del prodotto e nel “just in time” fattori di sviluppo industriale.
La teoria economica tradizionale afferma che il valore della produttività del lavoro non dipende solo dal prezzo delle merci prodotte ma anche dalla funzione dei costi, che sono funzione del processo produttivo impiegato.
La teoria delle forze produttive di List integra la teoria dei valori di scambio e la tradizionale teoria della produzione.
Essa studia un operatore economico raggiunga la capacità di produrre beni o servizi in modo continuato; analizza l’influenza sull’azione economica dell’imprenditore e del consumatore del sistema “politico amministrativo” in cui operano.
Il “politico amministrativo” è qui usato nel senso ampio: si ritiene che il sistema amministrativo di trasferimento culturale delle conoscenze tecniche e scientifiche, il funzionamento finanziario dello Stato, il modo di condurre le sue relazioni internazionali, l’ordine pubblico, l’amministrazione e la legislazione commerciale, l’efficienza amministrativa dell’apparato giudiziario dello Stato, la politica infrastrutturale dello Stato, siano legati da leggi economiche con l’azione dell’operatore economico, ne influenzino le scelte.
L’operatore economico massimizzante si rende conto del peso di questi vincoli politico amministrativi e concentra parte delle sue energie per modificarli a proprio vantaggio.
La teoria delle forze produttive, anche se partendo da premesse diverse, porta alle stesse conclusioni dei mercantilisti: l’intervento dello Stato in economia è necessario per assicurare il benessere nazionale; i dazi e il protezionismo possono essere necessari in determinati momenti storici per tutelare l’interesse nazionale.
Dalle teorie elaborate dalla scuola classica inglese e da Ricarc, Marx elaborò la teoria del plusvalore e la teoria della caduta del saggio di profitto.
Prevede: eliminazione proprietà privata e libera iniziativa; confisca dallo Stato dei beni privati; economia regolata da un piano quinquennale.
I fondamenti etici sono il materialismo storico e l’ideologia comunista (darwiniana secondo la quale dall’osservazione storica del tramonto delle società succedutesi nel tempo, allora anche il capitalismo subirà la stessa sorte).
Il valore di scambio di una merce è determinato, secondo Marx, dalla quantità di lavoro astratto racchiuso in essa e la quantità di lavoro è misurabile per durata temporale.
Il denaro consente gli scambi, perché funge da equivalente della merce.
Il denaro consente di stabilire, tramite la legge della domanda e dell’offerta, il prezzo di un bene sul mercato.
In una società mercantile esiste la circolazione merci-denaromerci: vi è la vendita della merce, dalla quale si ricava del denaro da reinvestire per l’acquisto di altra merce.
Nella società capitalista, la conversione di merce in denaro e del denaro in merce non è finalizzata al consumo della merce, ma all’aumento di denaro, ossia al profitto, plusvalore.
Si realizza il processo di scambio d-m-d’, in cui d’>d.
E’ la vendita della merce che consente di ottenere un profitto: il capitalista acquista materie prime e anche forza-lavoro, che è una merce, nella forma del salario.
La forza-lavoro ha un valore di scambio, quindi vale il tempo medio di lavoro necessario per produrla.
Il valore della forza lavoro non è calcolato al suo rendimento, ma sul costo necessario perché possa riprodursi.
Il capitalista corrisponderà all’operaio solo quanto è necessario alla sua sopravvivenza (alla riproduzione di forza-lavoro).
Se la parte di lavoro necessaria all’operaio per la propria sopravvivenza sono 5 ore, le altre ore di lavoro di quella giornata non gli sono pagate, quindi sono plus lavoro, che genera plusvalore o profitto.
La diminuzione del prezzo delle merci comporta la diminuzione del tempo necessario di lavoro perché la forza-lavoro si riproduca; la riduzione di tale tempo necessario comporta la diminuzione del salario.
Pertanto il valore dell’ora di lavoro non più necessaria all’operaio diventa un’ora in più di plus lavoro e perciò di plusvalore relativo.
Con macchinari più sofisticati ed efficaci, il costo della vita dell’operaio diminuisce.
Siccome diminuisce il salario aumenta il plus valore relativo.
Per fare questo il capitalista deve investire nuovo capitale e acquistare nuovi macchinari, senza aver del tutto ammortizzato i precedenti: aumenta il costo del capitale e diminuisce la partecipazione del lavoro alla produzione (che è quello che produce il plusvalore): questo comporta la diminuzione del saggio di profitto.
Diminuisce il tasso di plusvalore pv/v e muta la composizione del capitale investito; Con l’aumento nel processo produttivo del “capitale costante” e la diminuzione del lavoro, che produce plusvalore “pv”, il saggio di profitto p=pv/(c+v) diminuisce.
Il capitalismo è destinato a rendimenti decrescenti.
La teoria non tiene conto della formazione dei prezzi sul mercato e dell’innovazione tecnologica.
È poi trascurato il ruolo della moneta e del saggio di interesse nelle scelte dell’imprenditore (che si assume il rischio dell’attività economica).
Le idee di Marx avranno influenza sul pensiero filosofico e la politica dal novecento.
Marx fondò anche il partito comunista, e non comprese il ruolo delle banche e della finanza nello sviluppo economico, né l’importanza della libertà come caratteristica antropologica insopprimibile della natura umana.
In questa economia ogni scelta economica è decisa dallo Stato con un piano quinquennale, con una tavola di input output che stabilisce le risorse necessarie e i prodotti per l’intera popolazione.
I lavoratori e i membri del partito sono indirizzati ad un lavoro all’interno del piano.
La proprietà privata è inesistente e tutto appartiene allo Stato.
Non esiste libertà né politica, né economica.
Caratteristiche della teoria economica neoclassica, con fondatori Bentham e Mill: l’individualismo metodologico e l’utilitarismo; la teoria del valore-utilità (prezzo di una merce dipende da domanda ed offerta; la domanda è determinata sull’utilità marginale della merce e l’offerta sulla produttività marginare del lavoro e del capitale); la teoria della retribuzione dei fattori produttivi (il salario percepito dai lavoratori è solo la retribuzione del servizio del fattore lavoro ed il suo valore è calcolato secondo la produttività marginale; il profitto è la retribuzione del fattore capitale ed è la produttività marginale del capitale).
Questa teoria pone al centro dell’analisi economica l’individuo e i suoi processi di ottimizzazione e abbandona l’analisi del comportamento delle diverse classi economiche che erano state individuate dai classici (redditieri, lavoratori, capitalisti).
L’analisi economica è rivolta a trovare le condizioni di equilibrio parziale (Marshal) o generale (Walras, Pareto) dell’economia.
La domanda dei fattori della produzione è, nei neoclassici, una domanda derivata: la domanda di lavoro e di capitale è derivata dalla domanda dei beni per la cui produzione sono utilizzati quei fattori.
Nei neoclassici sono la scelta del livello della produzione e quella della tecnica di produzione a determinare la domanda di lavoro dell’impresa.
L’impresa non domanda lavoro solo in base all’andamento del mercato dei beni in cui opera, ma anche in riferimento al prezzo relativo dei fattori della produzione.
Questo è vero alla nascita dell’impresa.
Il primo principio della domanda dei fattori della produzione stabilisce che l’impresa utilizza processi produttivi con una sempre maggiore intensità di capitale all’aumentare del costo relativo del lavoro.
Più è alto il rapporto salario-rendimento del capitale, più sarà alto il rapporto capitale-lavoro.
Mentre questo principio è indiscutibile per comprendere le differenze suddette o per spiegare la scelta della tecnica di produzione quando nasce un’impresa, non è altrettanto valido quando gli impianti esistano già e ci sono variazioni nel rapporto salario-rendimento del capitale.
Capitale e lavoro sono altamente sostituibili se una data variazione nel rapporto salario-rendimento del capitale provoca una grande variazione nel rapporto capitale-lavoro.
Se l’impresa non muta il rapporto capitale lavoro quando si verificano grandi variazioni nel rapporto salario-rendimento del capitale, allora capitale e lavoro non sono facilmente sostituibili tra loro.
La sostituzione dei fattori è più semplice nel lungo periodo che non nel breve; in una piccola industria che non in una grande.
Nel breve periodo lo stock di capitale dell’impresa è fisso.
Dato il capitale, nel breve periodo l’impresa impiegherà un lavoratore in più solo se il beneficio che trarrà da ciò sarà maggiore o uguale al costo di quel lavoratore, espresso dal salario monetario.
Secondo i neoclassici, il contributo di un’ora addizionale è inferiore a quello dell’ora precedente: il lavoro, dato il capitale, offre un prodotto marginale decrescente.
Anche il prodotto marginale in valore, che è dato dal prodotto marginale per i prezzi, ha una funzione decrescente perché le imprese operano in regime di concorrenza perfetta e quindi non possono influenzare singolarmente i prezzi a cui riusciranno a vendere i loro prodotti.
Il salario monetario è invece uniforme: l’impresa per la prima ora di lavoro paga quanto per l’ultima.
Se l’impresa intende massimizzare i suoi profitti, domanderà lavoro fino a quando il salario è uguale al prodotto marginale in valore, ovvero fino a quando il salario reale sarà uguale al prodotto marginale in termini fisici.
Primo postulato della teoria neoclassica dell’occupazione: il salario è uguale al valore del prodotto marginale del lavoro.
In questo contesto scompaiono i problemi della teoria classica, poiché scompaiono sia la teoria del valore- lavoro che il conflitto tra le classi.
Il marginalismo combatte sia lo sviluppo marxista del pensiero degli economisti classici sia la scuola storica tedesca dell’economia: esistono leggi economiche che sottostanno in modo universale al comportamento economico dell’individuo ma queste leggi sono lontane dal plusvalore (perché il salario e il lavoro sono pagati correttamente per il loro contributo alla produzione e dalla caduta tendenziale del saggio di interesse).
Il Pensiero sociale cristiano sono tutte quelle scuole di pensiero economico che nascono come tentativo di applicazione pratica degli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa.
Il principio fondamentale è la dignità della persona, che poggia sulla libertà (capacità di ogni uomo di autodeterminarsi al bene e a Dio).
Il diritto alla vita biologica, di espressione, di parola, di culto, a formarsi una famiglia, di istruzione, di accedere a un lavoro, sono necessari tutti.
Tutti i diritti sono dei doveri.
Se non mi sento in dovere di rispettare la libertà altrui, non potrò invocare che sia rispettata la mia.
Secondo la Teologia cattolica, Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è all’uso di tutti gli uomini e popoli, senza escludere né privilegiare nessuno.
Il mondo e la sua terra è il primo dono di Dio per il sostentamento della vita umana.
Ogni uomo deve avere la possibilità di usufruire del benessere necessario al suo pieno sviluppo: l’uso comune dei beni è il primo principio dell’ordinamento etico-sociale ed è prioritario rispetto a qualunque intervento umano sui beni, compresi quelli della proprietà e del libero commercio.
La proprietà privata e il libero commercio sono legittimi ma il loro esercizio è subordinato alla destinazione universale dei beni: la proprietà privata e il libero commercio non devono intralciare la diffusione del benessere comune, ma facilitarne la realizzazione: tutti devono avere la proprietà e essere inseriti nei processi produttivi e commerciali, mentre eccessive concentrazioni di ricchezza nelle mani di pochi uomini sono pericolose per la vita spirituale e colpiscono la giustizia sociale.
La proprietà privata e il capitale devono essere equamente accessibili a tutti.
Pio XI introduce il principio di sussidiarietà nel 1931.
Secondo la Dottrina sociale della Chiesa, l’individualismo tipico delle società moderne è la conseguenza dello sradicamento della società civile, ovvero dei corpi sociali intermedi, attuato dalla rivoluzione francese e pianificato nella dottrina dello stato etico hegeliano.
Non esistono autori economici che abbiano tentato di formalizzare in un tentativo teorico i principi etici sviluppati dalla teologia morale del magistero cattolico.
L’influenza della Dottrina sociale cristiana è stata pratica, sull’azione dei partiti di ispirazione cristiana e di importanti politici.
L’unica vittoria concreta è stata l’accettazione del principio di sussidiarietà dell’Ue come fondamentale principio di democrazia, cardine della concezione dello stato, articolato secondo la gerarchia delle istituzioni, al servizio dei cittadini.
Secondo questo principio, se un cittadino non è in grado, con le sue forze, di raggiungere il proprio fine, ordinato al bene comune, spetta intervenire in loro aiuto alle istituzioni sociali più prossime, riconoscendo che la persona viene “prima” dello stato; non c’è democrazia, ma nemmeno partecipazione, senza sussidiarietà.
Tutto ciò favorisce la partecipazione di ogni cittadino (come dovere e diritto) alla costruzione del bene comune, alle condizioni capaci di agevolare il progetto di felicità che coinvolge famiglie e comunità di amici, in cui si esprime la vita quotidiana di ciascuno; con il coraggio di guardare oltre il limite dei soli beni materiali o culturali.
Keynes è un economista malthusiano.
I suoi fondamenti sono in parte classici, in parte neoclassici.
Keynes ha un vantaggio rispetto ad essi: comprende il ruolo fondamentale della moneta nell’economia e l’importanza della macroeconomia.
I neoclassici e i liberisti hanno torto nelle loro indicazioni di Politica economica.
Nel mercato non si realizza automaticamente la piena occupazione.
Occorre riprendere lo studio delle variabili macroeconomiche.
Secondo Keynes occorre studiare il funzionamento della Borsa, della moneta, della bilancia dei pagamenti e delle variabili macroeconomiche e questo consente ai governi di attuare interventi necessari a raggiungere la piena occupazione, stabilità dei prezzi ed equilibrio della bilancia dei pagamenti.
I classici e i neoclassici sbagliano a ritenere che il sistema raggiunga l’equilibrio sui mercati nazionali e internazionali senza l’intervento regolatore dell’attività economica dallo Stato.
Esiste una differenza tra l’intervento prescritto dai mercantilisti, la politica economica della scuola storica tedesca e Keynes.
L’intervento non serve per arricchire la Nazione e permetterle di conquistare altri Stati e popoli e costruire l’impero, non si tratta di far vincere una Nazione sulle altre.
Lo studio della macroeconomia e l’intervento di politica economica servono a raggiungere punti di equilibrio e non di surplus: la bilancia dei pagamenti non deve essere in surplus, ma in pareggio, lo Stato deve perseguire la piena occupazione, ma non con le commesse militari o riorganizzando l’esercito.
Lo Stato deve impedire l’inflazione perché questa colpisce il risparmio e deve regolamentare i mercati finanziari.
La politica espansiva della spesa pubblica e della moneta, invece di ottenere la piena occupazione condussero a debiti pubblici e inflazione.
Gli economisti si trovarono di fronte a problemi dovuti non al fallimento dei mercati come nel 1929, ma a problemi generati dagli interventi di politica economica prescritti da una certa interpretazione del pensiero Keynesiano.
Friedman e Lucas fonderanno due scuole economiche critiche nei confronti delle politiche interventiste Keynesiane.
Per loro l’intervento dello Stato peggiora e non migliora l’economia e propongono di tornare al liberismo.
I guasti determinati dall’eccesso di intervento dello Stato in economia determinarono il ritorno alle politiche liberiste ispirate dalla scuola monetarista.
Negli anni 80 il federal reserve board innalza al 25% la soglia di realizzo degli istituti di credito sui propri utili e istituisce il ricorso al leveraged buyout; la presidenza Clinton interrompe nel 99 la separazione del sistema bancario tra attività bancaria commerciale e d’investimento e legittimando la nascita di grandi conglomerati finanziari; in Eu le BC furono rese indipendenti dal potere esecutivo e sollevate dall’obbligo di finanziare i debiti pubblici statali; banche, fondi finanziari e fondi pensione furono liberalizzati e acquisiti da soggetti privati; la circolazione internazionale dei capitali fu liberalizzata e non più sottoposta a controlli preventivi o a regole di movimentazione; furono rimossi vincoli, come quello dei massimali di credito (divieto di erogare credito oltre certe soglie) o dell’obbligo di acquistare quote di titoli di debito nazionale per le istituzioni economiche controllate dallo Stato.
Risultato: afflussi di capitali più massicci, nuova fase economica “post-industriale” in cui gli investimenti finanziari, soprattutto speculativi, sono più redditizi di quelli produttivi.
Nel 2008 Lehman Brothers ha annunciato di voler avvalersi del chapter 11 del bankruptcy code statunitense, una procedura simile al concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare italiana, annunciando debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per 639 miliardi.
Bancarotta generata dalla bolla speculativa dei mutui sub prime.
Le banche americane, con l’erogazione dei mutui sub prime, hanno trasformato il mutuo, uno strumento molto semplice di finanziamento per l’acquisto di un immobile tutelato da ipoteca, in una pratica predatoria.
Le banche hanno erogato mutui a persone che non avrebbero potuto restituire il prestito per mancanza di reddito.
Questo è dipeso dalla mancanza di una supervisione dalle autorità governative.
Tutti gli operatori hanno agito senza deontologia ed etica: i mediatori creditizi hanno indirizzato i debitori verso prestiti che non potevano soddisfare; i periti hanno gonfiato le valutazioni degli immobili, gli investitori hanno scommesso sui titoli che incorporavano mutui sub prime, che molti sapevano essere delle truffe al solo fine speculativo, convinti di potersi liberare del titolo un momento prima del crollo.
Se è vero che un eccessivo interventismo statale nell’economia è portatore di grossi problemi, la soluzione non può essere il ritorno ai precetti liberali, perché l’evidenza storica dimostra che i mercati, lasciati a se stessi, non sono in grado di auto regolamentarsi e giungere all’equilibrio.
Occorre dunque trovare un punto di equilibrio e studiare quali attività lo Stato deve svolgere e quali possono essere lasciate al mercato.
Secondo Keynes l’andamento delle Borse non ha relazione con l’andamento dell’economia reale.
La Borsa è la speculazione, il posto in cui si scommette sul valore che le azioni avranno qualche ora dopo.
Qualcuno perde, qualcuno vince, ma il saldo è zero.
Lo sviluppo economico dipende invece dall’innovazione tecnologica, dalla capacità di trasformare le invenzioni e le innovazioni in nuovi prodotti e processi.
L’attuale crisi economica mondiale è conseguenza dell’applicazione dei modelli economici neoliberisti della scuola monetarista (secondo cui l’intervento dello Stato nell’economia produce solo debito pubblico e inflazione).