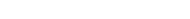Nel 1958 venne pubblicato dalla Rivista Economica un articolo del professore Phillips dal titolo “La relazione tra la disoccupazione e il saggio di variazione del salario monetario nel Regno Unito, 1861- 1957.
Secondo la curva di Philips, è possibile ridurre la disoccupazione solo se si accetta un aumento dell’inflazione.
Qui il tasso di variazione dei prezzi dipende dalle variazioni del tasso di disoccupazione (nella originaria la variazione dei salari nominali dipende dalle variazioni della disoccupazione).” Ipotesi curva originaria; che cosa influenza i salari:
– la disoccupazione.
I salari non sono flessibili.
I lavoratori riescono ad ottenere forti incrementi dei salari quando la domanda di lavoro è alta e la disoccupazione bassa, ma sono riluttanti a lavorare a salari minori di quelli abituali quando la domanda di lavoro è bassa e la disoccupazione alta, di modo che in queste fasi i salari nominali diminuiscono lentamente.
La relazione tra la disoccupazione e il saggio di variazione del salario nominale è non lineare.
– la domanda di lavoro che deriva da fasi espansive dell’economia indipendentemente dal livello di disoccupazione.
Come conseguenza della specializzazione dell’attività lavorativa, in una fase di espansione, può aversi scarsezza di manodopera, mentre vi è ancora un elevata disoccupazione.
In tali condizioni i salari nominali aumentano prima che sia raggiunto il pieno impiego.
– il saggio di variazione dei prezzi al dettaglio, i quali variano molto in seguito a variazioni dei prezzi delle merci importate.
Occorre, secondo Phillips, che la variazione dei prezzi all’importazione sia consistente, perché questa possa, con aggiustamenti della scala mobile, agire sui tassi di variazione dei salari nominali.
Phillips si propose di verificare se l’evidenza statistica avvalorasse l’ipotesi che il saggio di variazione dei salari monetari in Gran Bretagna potesse essere spiegato dalla disoccupazione e dal suo saggio di variazione.
Phillips studiò i periodi 1861-1913, 1913- 1948 e 1948-1957.
La curva nel periodo 1861-1913 disegnò un diagramma a dispersione del tasso di variazione dei saggi di salario e della % di disoccupazione.
Individuò 6,5 cicli economici con una durata media di otto anni.
Poi disegnò i diagrammi a dispersione per gli anni di ciascun ciclo.
Ogni punto di ogni diagramma è un anno, essendo il tasso medio di variazione dei saggi salariali monetari durante l’anno dato dalla scala dell’asse verticale e la disoccupazione media durante l’anno dalla scala dell’asse orizzontale.
Il tasso di variazione dei saggi di salario monetario fu calcolato dall’indice dei saggi di salario orario costruito da Brown e Hopkins.
Le % sulla disoccupazione furono quelle calcolate dal Board of Trade e dal Ministero del Lavoro.
Vi era una tendenza del tasso di variazione dei saggi monetari salariali ad essere alti quando la disoccupazione era bassa e ad essere bassi quando la disoccupazione era alta.
Vi era anche una tendenza del tasso di variazione dei saggi di salario monetario ad ogni livello di disoccupazione a trovarsi al di sopra della media, a quel livello di disoccupazione, quando l’occupazione era crescente, cioè durante le fasi di espansione economica; e a trovarsi al disotto quando l’occupazione diminuiva, cioè nella fase recessiva.
La variazione dei salari monetari era spiegata dalla trazione della domanda.
Nel primo diagramma a dispersione venivano indicati con delle croci i valori medi del tasso di variazione dei saggi di salario monetario e della disoccupazione di quegli anni in cui la disoccupazione si situava tra 0-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-7, 7 e 11%: ogni croce dava un’approssimazione del tasso di variazione dei salari che sarebbe stato associato al livello di disoccupazione se la disoccupazione si fosse mantenuta costante a quel livello.
La curva di Phillips fu ottenuta interpolando le croci.
La forma dell’equazione scelta fu: y+a=bxc, dove y è il tasso di variazione dei saggi di salario e x la % della disoccupazione.
Le costanti b e c furono stimate con il metodo dei minimi quadrati usando i valori di y e x corrispondenti alle croci nei quattro intervalli tra 0 e 5% di disoccupazione (variabile indipendente è la disoccupazione, i salari sono la variabile dipendente).
La costante a fu scelta per tentativi, in modo da far passare la curva il più vicino possibile alle due rimanenti croci negli intervalli tra il 5 e l’ 11% di disoccupazione.
L’equazione della curva interpolata è: y+0,900=9,638x-1,394 Phillips osservò poi le variazioni dei salari nei singoli anni in relazione alla curva trovata e tenendo conto dei cicli economici individuati, ed osservò che gli aumenti salariali del 1862 non erano spiegati dalla relazione con il livello e il saggio di variazione della disoccupazione.
Gli parve che l’aumento del 12,5% dei prezzi all’importazione tra il 1861 e il 1862, connesso con lo scoppio della guerra civile americana, spiegasse bene perché gli aumenti salariali furono connessi in quell’anno all’aumento del costo della vita piuttosto che all’andamento della domanda di lavoro dagli imprenditori.
La relazione tra il tasso di variazione dei saggi di salario e il livello e il tasso di variazione della disoccupazione era incontrovertibile e netta nel secondo ciclo economico considerato (1868-1879).
La relazione non compariva nel terzo ciclo economico.
Phillips notò che, se si sostituiva l’indice dei salari di Brown e Hopkins con l’indice del Bowley, la relazione tipica veniva verificata anche per questo periodo (1879-1886).
Era intervenuto qualche fattore di disturbo nella costruzione dell’indice per quegli anni.
La relazione era verificata nel ciclo economico 1886-1893.
Nel ciclo economico 1893-1904 si ha un rallentamento della crescita dei salari nelle fasi espansive, cioè una riduzione della variazione dei salari nominali dovuta alla trazione da domanda.
Phillips spiegò questo rallentamento con l’opposizione agli aumenti salariali che si registrò dal 1894 al 1896, culminati nel conflitto industriale del 1897.
Nel ciclo 1909-1913 la relazione venne disturbata nel 1912 con lo sciopero generale nelle miniere di carbone.
Correggendo il valore della disoccupazione tale da tener conto degli effetti distorsivi introdotti dallo sciopero, Phillips dimostrò che la relazione era verificata anche per quell’anno.
Osservò quindi che l’ampiezza delle oscillazioni ottenute in ogni ciclo economico avevano avuto la tendenza a restringersi indicando una riduzione della dipendenza del tasso di variazione dei salari monetari dalla variazione del livello e del tasso di variazione della disoccupazione.
Due spiegazioni possibili: – il professore Brown aveva osservato che, prima della prima guerra mondiale, nel settore carbonifero e dell’acciaio erano diffusi aggiustamenti automatici di scala mobile, e questo aveva rafforzato la dipendenza delle variazioni salariali dalle variazioni della disoccupazione in tali settori.
Nei primi anni del periodo questi settori avrebbero avuto pesi grandi nell’indice dei salari ma, data la maggiore ampiezza del repertorio statistico disponibile negli anni successivi, i pesi di questi settori nell’indice si sarebbero ridotti.
Secondo Phillips la diminuzione dell’ampiezza delle oscillazioni scaturiva non da una riduzione nella dipendenza delle variazioni dei salari dalle variazioni della disoccupazione, ma da un ritardo temporale nella rispondenza delle variazioni delle variabili considerate, causata dall’estensione di contratti collettivi e dall’introduzione di procedure di arbitrato e conciliazione.
Tra il 1913-1948 furono usati l’indice dei tassi di salario orario della fine di dicembre di ogni anno e i dati sulla percentuale di disoccupazione, forniti dal Ministero del Lavoro.
Per questi anni la relazione parve meno evidente, ma Phillips dette una spiegazione delle variazioni che differivano: gli anni per i quali la relazione era meno evidente erano quelli in cui si era verificato un aumento rapido dei prezzi all’importazione, che aveva influito sui salari nominali e aveva controbilanciato la tendenza della crescente produttività a ridurre il costo della vita.
Nella prima guerra mondiale la disoccupazione fu bassa e i tassi di salario aumentarono.
Si diffusero accordi automatici che agganciavano i salari al costo della vita.
Per quegli anni Phillips non seppe chiarire se gli adeguamenti al costo della vita fossero un fattore reale di aumento dei tassi di salario o se quegli aumenti si sarebbero verificati comunque come conseguenza dell’alta domanda di lavoro e della trazione della domanda.
Nel 1920 vi fu poi un aumento della disoccupazione dal 2,6 al 17%, e una caduta del 22,2% dei saggi di salario nel 1921 (spiegata questa dal rapido aumento della disoccupazione e dalla caduta del 12,8% nel costo della vita).
Phillips individuò nella caduta dei prezzi la causa principale della caduta del salario.
Dal 1925 al 1929 la disoccupazione rimase stabile tra il 9,7% e il 12,5%.
La causa del persistere della disoccupazione dipese dalla decisione di deprimere la domanda nel tentativo di spingere verso il basso il livello dei prezzi per ristabilire il gold standard alla parità prebellica.
Il livello medio di disoccupazione in questi cinque anni fu del 0,94% e il tasso medio di variazione dei saggi di salario fu di -0,60% all’anno.
Questi valori rispondevano a quelli presenti lungo la curva trovata per il periodo 1861-1913.
Il ciclo 1929- 1937 ha più disoccupazione.
Qui l’autore mise in evidenza l’azione di un secondo fattore sul saggio di variazione dei salari nominali: la distribuzione geografica diversificata della disoccupazione che aveva accelerato l’incremento dei salari nella fase ascendente dell’attività economica nel periodo ’34-’37.
1948-1957: La curva a dispersione per questi anni fu costruita con dati dedotti dal Ministry of Labour Gazette.
Nel ’48 si registrò un aumento dei prezzi al dettaglio, causato dal rapido aumento dei prezzi all’importazione registrato nel 1947.
Gli aumenti salariali del’49 furono bassi grazie alla politica di restrizione salariale introdotta da Cripps nel 1948.
Gli aumenti dei prezzi all’importazione degli anni ’50-’51 e ’51-’52 furono la causa degli aumenti dei prezzi al dettaglio che provocò aumenti da scala mobile dei saggi di salario.
Phillips notò che c’era un ritardo temporale di sette mesi nell’adeguamento dei salari al nuovo livello e saggio di disoccupazione il nuovo diagramma a dispersione che ne derivava mostrava l’andamento tipico della curva trovata riferita al 1861-1913.
L’autore costruì una tabella riportante sulla prima colonna le variazioni percentuali dei saggi di salario monetario.
Nella seconda le % di cui ci si sarebbe aspettato che salissero i saggi di salario, dato il livello di occupazione di ogni anno, in conseguenza della gara tra gli imprenditori per accaparrarsi il lavoro; queste % sono l’elemento della trazione da domanda negli aggiustamenti salariali.
Nella terza colonna pose l’elemento spinta da costi: l’aumento % manifestato dall’indice dei prezzi al minuto, nel mese in cui le trattative hanno luogo, rispetto all’indice del mese corrispondente dell’anno passato.
Nella quarta colonna la variazione dei prezzi all’importazione.
L’elemento costo nelle trattative salariali aveva avuto il sopravvento negli anni ’48, ’49, ’51, ’52 e dal ’53 in poi era l’elemento trazione da domanda ad essere stato rilevante: gli incrementi salariali erano stati uguali o poco inferiori a quelli della tabella trazione della domanda.
“Ignorando gli anni in cui i prezzi all’importazione salirono tanto da dare inizio ad una spirale prezzi salari, e supponendo un aumento della produttività del 2% all’anno, si deduce che, se la domanda fosse mantenuta a un valore tale da mantenere un livello dei prezzi dei prodotti stabile, il connesso livello di disoccupazione rimarrebbe un po’ al disotto del 2,5%.
Se la domanda fosse mantenuta a un livello salariale stabile, il connesso livello di disoccupazione si manterrebbe sul 5 e 12 %”.
La curva di Phillips considera le variazioni del tasso di variazione di salario dipendenti alle variazioni del tasso di variazione della disoccupazione.
Lungo la curva di Phillips un salario monetario stabile coincide con una disoccupazione del 5,5%.
Una domanda effettiva capace di mantenere un livello di disoccupazione inferiore, pari al 2,5%, genererebbe un incremento salariale medio annuo del 2%.
Se si suppone esistere un aumento della produttività del 2% all’anno, l’aumento dei salari non si ripercuoterebbe sui prezzi e non genererebbe inflazione.
Un aumento della produttività è un incremento dei guadagni dalle imprese, che comporta uno spostamento verso destra della curva del valore della produttività marginale decrescente della singola impresa: sulla nuova curva di domanda del lavoro l’impresa può occupare o un maggior numero di operai o lo stesso numero dell’anno precedente ad un salario leggermente superiore.
Prima di raggiungere la piena occupazione, la concorrenza tra imprenditori per ottenere la manodopera migliore determinerà un aumento dei salari nominali, piuttosto che un aumento dell’occupazione.
L’indicazione di Politica economica è di contenere l’incremento dei salari, inevitabile a causa della concorrenza per la manodopera migliore, nei limiti degli incrementi della produttività.
La tematica del tradeoff tra inflazione e disoccupazione è estranea alla curva di Phillips.
La teoria occupazionale di Phillips è di matrice keynesiana: secondo Phillips è la domanda globale che determina il livello di produzione e di occupazione.
Anche se non si può dire che l’economista ignori il salario reale, solo in un sistema economico che assista ad un incremento della produttività pari o maggiore all’incremento dei salari nominali viene considerata attuabile una politica economica che mantenga un livello di disoccupazione del 2,5%.
Nella versione originaria del lavoro di Phillips la produttività del lavoro e salario reale sono presenti, anche se come limite alla domanda effettiva.
In realtà la curva di Phillips dimostra che è difficilmente perseguibile una disoccupazione inferiore a quel livello e questo per la lotta che si verifica durante le fasi espansive dell’economia tra gli imprenditori per ottenere la manodopera più qualificata.
Al di sotto del 2,5% della disoccupazione, l’incremento della produttività non è più capace di compensare l’incremento determinato nei salari nominali e i prezzi aumenteranno.
Il contesto generale può essere complicato dall’aumento dei prezzi delle merci importate e dalle fluttuazioni cicliche dell’economia.
Phillips: “Io ho suggerito che un livello di disoccupazione leggermente più alto del 2%, potrebbe essere accettato come condizione necessaria per moderare la velocità dell’inflazione”.
L’incremento dei salari deve essere contenuto al livello medio annuo della produttività.
Le critiche principali: se il tasso di sviluppo fosse stato più rapido, i prezzi non sarebbero cresciuti così rapidamente.
Il tasso di sviluppo dell’economia con una disoccupazione costante del 2% sarebbe stato inferiore al tasso di sviluppo di un’economia con una disoccupazione inferiore.
Phillips non condivideva questa critica perché riteneva che solo il livello degli investimenti e non quello dell’occupazione influiva sul tasso di sviluppo dell’economia.
Altra critica: le politiche economiche meno espansive di quelle prima attuate avrebbero sfavorito gli investimenti delle imprese, ma secondo Phillips era solo il saggio d’interesse d’equilibrio a determinare il livello degli investimenti.
Secondo lui la politica economica non doveva perseguire la piena occupazione, ma i prezzi sufficientemente costanti anche se accompagnati da una disoccupazione del 2,5%.
Philips dice di contenere le politiche espansive nell’ambito dell’incremento della produttività per non generare aumento dei prezzi dei prodotti.
La teoria nelle università all’epoca era quella keynesiana e la curva di Phillips era in grado di dare una
spiegazione dell’andamento dei salari nominali.
La relazione statistica di Phillips sembrava colmare una lacuna della Teoria Generale.
Molti sostituirono all’originaria relazione tra il saggio di variazione dei salari nominali e i livelli di disoccupazione, una relazione che associava ai livelli di disoccupazione i livelli e i saggi di variazione dell’inflazione.
Il passaggio dall’originaria relazione a quella tra saggio di variazione veniva giustificato con l’introduzione del mark-up, che suppone che le imprese fissino il prezzo dei prodotti applicando un margine di profitto ai costi, comprendendo nei costi i salari pagati ai lavoratori.
La curva di Phillips divenne la relazione empirica che dimostrava l’esistenza di un trade-off tra inflazione e disoccupazione, e dimostrava che l’obiettivo della piena occupazione era perseguibile solo se accompagnato da un processo inflazionistico.
Data la priorità che si dava all’epoca al perseguimento della piena occupazione, equivaleva ad affermare che l’inflazione era un buono stimolo all’economia e che non si potevano perseguire entrambi gli obiettivi: un’alta occupazione e un livello dei prezzi costanti.
Phillips teneva in considerazione gli incrementi della produttività del lavoro e il contesto competitivo delle imprese per evitare che gli incrementi del salario nominale facessero aumentare i prezzi.
Di fronte al manifestarsi dell’inflazione, il tradeoff forniva una giustificazione economica del suo verificarsi.
L’inflazione diveniva il prezzo da pagare per raggiungere la piena occupazione, oppure occorreva un sacrificio in termini di occupazione per contrastare attivamente l’inflazione.
L’aumento dell’inflazione e della disoccupazione negli anni ’70 sconfessò la validità del trade-off tra le due variabili.
Questo dette vita ad una reazione al sistema keynesiano.
Nella curva originaria sulla x c’è il tasso di disoccupazione e sulla y il tasso di rotazione dei salari nominali.
Lungo l’originaria curva di Phillips, una domanda effettiva capace di mantenere una disoccupazione pari al 2,5%, genera un incremento salariale medio annuo del 2%.
Se si suppone esistere un aumento della produttività annuo del 2%, la politica espansiva della domanda non genererà non inflazione.
Affinché la politica espansiva della domanda non generi inflazione è necessario che l’incremento dei salari nominali sia contenuto al livello medio annuo della produttività.
La versione modificata prevede il trade off tra inflazione e occupazione.
Qui non si studia più la variazione dei salari nominali al variare della disoccupazione, ma si giunge alla convinzione che la disoccupazione può essere scambiata con un certo livello di inflazione.
Sulla x c’è il tasso di disoccupazione e sulla y il tasso di variazione dei prezzi.
“Il dibattito sulla curva di Phillips è iniziato nel 1926.
Ci sono voluti 45 anni per completare il ciclo.
Una dimostrazione di come lo sviluppo tecnologico abbia accelerato la creazione e dissipazione dell’ignoranza”.
Nel 1926 Fisher pubblicò nella “International Labour Review” un articolo “A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes”.
Fischer era rimasto colpito dall’osservazione che l’inflazione tendeva ad essere associata a bassi livelli di disoccupazione e la deflazione ad alti livelli di disoccupazione.
Egli stimò la relazione statistica esistente tra l’inflazione e la disoccupazione.
Nel suo ragionamento era il tasso di variazione dei prezzi che dava inizio al processo.
La variabile indipendente era l’inflazione.
Si supponga che si verifichi un tasso di crescita della spesa maggiore di quello previsto.
I produttori lo interpreteranno come un aumento della domanda reale dei prodotti.
Fischer sostiene che, in prima istanza, ciascun produttore sarebbe tentato di espandere la propria produzione e di lasciare crescere i prezzi.
Secondo Fischer la disoccupazione dipende dalla variazione dei prezzi.
All’inizio la maggior parte dell’aumento non previsto della domanda nominale sarebbe assorbita da incrementi dell’occupazione e della produzione piuttosto che da incrementi dei prezzi.
Quando, invece, la spesa diminuisce, ciò genera un rallentamento della produzione e una crescita della disoccupazione.
Friedman era stato condizionato dall’atmosfera intellettuale generata dalla rivoluzione keynesiana ed aveva erroneamente invertito l’ordine di causalità tra le due variabili: in Phillips è il livello e il tasso di variazione dell’occupazione la variabile indipendente che mette in moto il processo.
L’errore di Phillips era l’invertire l’ordine di causalità tra le due variabili.
Perché Phillips, secondo Friedman, aveva confuso i salari nominali con i salari reali? La maggior parte delle ricerche avevano dimostrato l’incapacità della curva di Phillips di avere validità per altri gruppi di dati.
I fallimenti nelle stime empiriche hanno portato molti economisti ad un tentativo di salvare l’approccio basato sulla curva di Phillips distinguendo una curva di breve da una di lungo periodo.
La nuova curva di Phillips (breve è il secondo grafico) è stata così costruita: sulle ordinate è stato posto il salario reale anticipato; sulle ascisse i livelli di disoccupazione.
Se si suppone che le previsioni sul livello dei prezzi mutino lentamente, e se si riesce a conoscere con poco ritardo la rapida variazione del salario nominale, è possibile ritornare, per brevi periodi, alla formulazione originale di Phillips.
Qui, i prezzi correnti si potrebbero aggiustare con la stessa o maggiore rapidità dei salari.
I salari reali correnti si potrebbero muovere in direzione opposta a quelli nominali, mentre i salari reali anticipati si muoveranno nella stessa direzione.
Nel breve periodo la disoccupazione diminuisce perché i salari reali correnti diminuiscono.
E’ l’illusione monetaria a consentire il funzionamento del meccanismo.
La relazione espressa dalla curva di Phillips è: (1/W ∙ dW/dt) – (1/P ∙dP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale dei dW/dt) – (1/P ∙ dW/dt) – (1/P ∙dP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale deidP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale dei prezzi e U è la disoccupazione.
L’aumento della domanda aggregata determina un incremento del saggio di variazione dei prezzi e dei salari al tasso del 3% annuo.
I lavoratori non si accorgono del contemporaneo incremento dei prezzi e interpretano l’incremento dei salari nominali come una crescita dei salari reali.
Sono disposti ad offrire più lavoro.
Sulle ordinate poniamo il salario reale anticipato: (1/W ∙ dW/dt) – (1/P ∙dP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale dei dW/dt) – (1/P ∙ dW/dt) – (1/P ∙dP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale dei dP/dt) = f (U).
La disoccupazione nel breve periodo diminuisce.
Gli imprenditori occupano più lavoratori perché si accorgono che i salari reali correnti diminuiscono.
Nel caso opposto, la diminuzione della domanda aggregata comporta un aumento della disoccupazione.
Le aspettative adattive.
Friedman propone un’altra revisione della curva di Phillips.
Sull’asse verticale riportata il tasso di variazione dei salari nominali, e sull’asse orizzontale la disoccupazione.
Le aspettative sui prezzi vengono incorporate tracciando curve tra loro differenti, una per ogni tasso anticipato di crescita dei salari.
Algebricamente la relazione espressa dalla curva di Phillips può essere scritta: (1/W ∙ dW/dt) – (1/P ∙dP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale dei dW/dt)=f[U(1/P ∙ dW/dt) – (1/P ∙dP/dt)=f(U) dove W è il salario nominale, P è il livello generale dei dP/dt)].
La curva indica una situazione più simile a quella di Fischer che a quella di Phillips.
Supponiamo che da una situazione d’equilibrio, con prezzi e salari costanti, un’espansione economica faccia crescere la domanda aggregata nominale, la quale determina una crescita dei prezzi e dei salari al 3% annuo.
Inizialmente, i lavoratori interpreteranno questo fatto come una crescita dei salari reali, dal momento che prevedono ancora prezzi costanti, e quindi vorranno offrire più lavoro.
Occorre distinguere due momenti: prima, una crescita della domanda e del prezzo di un bene da essi prodotto sarà interpretata come una crescita del suo prezzo relativo, e ciò implica una caduta del salario reale che essi devono pagare, misurata in termini di prodotto.
Essi assumeranno più lavoro perché parrà di aumentare i profitti.
Il risultato congiunto è un aumento dell’occupazione e un aumento dell’inflazione; poi c on il passare del tempo i datori di lavoro e i lavoratori riconoscono che a crescere sono i prezzi in generale.
Essi modificano verso l’alto le loro stime sul tasso di inflazione.
La curva di Phillips di breve periodo si sposta verso l’alto.
Quando il tasso anticipato di variazione dei prezzi uguaglia il tasso d’inflazione effettivo, la disoccupazione torna al suo livello originario, o poco al di sotto di esso (G).
Nella figura sopra, un’inflazione del 3% comporta un aumento dell’occupazione quando il tasso anticipato di variazione dei prezzi è uguale a O (aspettativa 1).
La disoccupazione passa da F a E.
Con il passare del tempo i lavoratori adattano il tasso anticipato di variazione dei prezzi al tasso d’inflazione effettivo.
La curva di Phillips di breve periodo si sposterà verso l’alto e il nuovo punto di equilibrio sarà G sulla curva di Phillips di breve periodo in cui il tasso anticipato di inflazione uguaglia il tasso corrente.
E’ necessario stabilire dove si posizionerà la curva di Phillips di breve periodo.
Nella nuova curva di Phillips, la curva di lungo periodo sarebbe leggermente inclinata negativamente, come la LL.
Se, invece, la relazione di Phillips di breve periodo che incorpora le aspettative inflazionistiche è espressa dalla curva rappresentata nella figura sopra, la curva di lungo periodo è verticale.
Ecco emergere il ruolo delle aspettative inflazionistiche nel permettere o meno il trade-off tra inflazione e disoccupazione.
Il trade-off esiste nel breve periodo e non nel lungo.
Il giudizio di Friedman sulla curva di Phillips è che essa è ingannevole perché sovrastima il trade-off di breve periodo.
L’opinione di Friedman è che il trade-off di lungo periodo sia zero.
Il professor Phelps avanzò la stessa ipotesi, ma con motivazioni diverse.
L’ipotesi di questi economisti è stata chiamata ipotesi accelerazionista o del tasso naturale.
Entrambi gli studiosi, concordando sull’ipotesi che la curva di lungo periodo sia verticale, affermano che solo un’inflazione accelerata può permettere una riduzione della disoccupazione al disotto del suo livello strutturale.
Adattandosi alle aspettative al tasso di inflazione realizzato, occorre accelerare l’inflazione per evitare un ritorno dell’occupazione al livello originario.
Questo livello d’occupazione, coerente con le condizioni esistenti nel mercato del lavoro, fu chiamato da Friedman tasso naturale di disoccupazione (livello di disoccupazione che non dipende da fenomeni monetari).
Molti economisti criticarono Friedman perché interpretarono il tasso naturale di disoccupazione come il livello minimo non eliminabile della disoccupazione, ma in realtà è quel livello di disoccupazione che è ineliminabile con le variabili macroeconomiche, ma che può essere rimosso riducendo le frizioni o gli elementi che impediscono un efficiente funzionamento del mercato del lavoro.
Friedman: “bisogna separare l’aspetto monetario dell’occupazione da quello non monetario”.
Friedman dice quindi che non si può raggiungere un obiettivo occupazionale diverso dal tasso naturale attraverso una qualsiasi regola fissa.
Il solo modo di raggiungere un’occupazione maggiore del tasso naturale di occupazione è essere sempre più abili degli agenti economici, predisponendo continuamente nuove regole e adattandole per un periodo di tempo, fino a quando gli operatori economici riusciranno ad individuarle.
Allora le autorità dovranno inventare nuove regole.
Il giudizio riguardo ad una tale politica economica è negativo.
Secondo Friedman il migliore approccio alla politica economica è cooperare con gli agenti economici, informandoli sulle politiche che si intende attuare, piuttosto che ingannarli “ci si inganna se si pensa di poter ingannare gli altri”.
Friedman è un monetarista, secondo cui le fluttuazioni cicliche sono riconducibili all’andamento dell’offerta di moneta, e ha dato spiegazione dei fenomeni storici in termini monetari nella sua “Storia Monetaria degli Stati Uniti d’America dal 1867 al 1960”.
Interessanti sono le manovre di politica economica che Friedman ritiene utili per combattere l’inflazione, come l’indicizzazione dei contratti di lavoro.
Secondo Friedman è necessario diffondere l’indicizzazione delle tasse, del debito pubblico e di tutti contratti economici per contrastare meglio l’inflazione e migliorare le istituzioni.
Tutti gli economisti conoscono il Fiscal-drag: fenomeno dovuto alla progressività delle imposte, che viene applicata ai redditi monetari, per cui i contribuenti, a causa dell’inflazione, pagano un’imposta maggiore, mentre, in realtà, all’aumento del reddito monetario non corrisponde un aumento del potere d’acquisto.
L’inflazione, se la tassazione non viene indicizzata, permette di aumentare il gettito fiscale, senza approvare il nuovo livello impositivo con una legge.
L’indicizzazione della tassazione è una necessità prioritaria per migliorare la struttura politica, per porre i legislatori di fronte alle loro responsabilità, in ordine all’imposizione fiscale e alle spese che deliberano.
Tecnicamente ciò si dovrebbe raggiungere moltiplicando gli scaglioni di reddito per l’indice dei prezzi.
Adeguando la base per il calcolo dei guadagni sui capitali al mutamento dei prezzi tra periodo di acquisto e di vendita.
Calcolando in modo simile l’ammortamento e il valore delle scorte.
Secondo Friedman è necessaria anche l’indicizzazione dei titoli di Stato.
Molti economisti ritengono che emettere titoli pubblici indicizzati non sarebbe una buona cosa perché eliminerebbero dall’economia un elemento antinflazionistico; con l’indicizzazione, l’inflazione aggiunge altre spese a carico del bilancio, mentre senza indicizzazione le spese rimangono le stesse e le entrate fiscali aumentano.
Secondo questi economisti, i titoli pubblici non indicizzati sono antinflazionistici.
Friedman non condivide questa impostazione perché è convinto che i legislatori spendano sempre tutto il gettito che il sistema fiscale riesce a determinare.
L’argomentazione dei suoi critici viene a cadere perché l’aumento delle entrate fiscali determinerà, secondo Friedman, un aumento della spesa.
Friedman: “il modo per imporre una disciplina fiscale è ridurre l’entrata”.
Friedman è favorevole ad una politica di sgravi fiscali.
L’indicizzazione dei titoli pubblici è necessaria per responsabilizzare la spesa pubblica.
Friedman è favorevole all’estensione degli accordi di indicizzazione che è compito del governo diffondere in tutti i contratti tra privati: l’indicizzazione dovrebbe attuarsi volontariamente per l’interesse spontaneo del pubblico.
Per i contratti di lavoro, l’obiezione maggiore è che l’indicizzazione impedirebbe la riduzione dei salari reali, se fosse necessario.
Friedman ha rifiutato questa critica: ” l’indicizzazione è un procedimento inteso ad adeguare prima di una nuova contrattazione quanto si è in precedenza convenuto.
Un nuovo contratto può essere negoziato ad un livello più alto dei salari reali, o a un livello più basso.
L’indicizzazione fa in modo che, qualunque sia il contenuto dell’accordo raggiunto, le due parti l’otterranno.
E’ un modo di mettere in grado la gente di impegnarsi in contratti reali”.
Per Friedman non esiste un’inflazione da costi, tutte le inflazioni sono dovute ad un eccesso della domanda.
I sindacati non sono la causa dell’inflazione, mentre è causa di inflazione la cattiva politica economica perseguita dai politici.
Qui assume priorità la lotta contro l’uso della politica monetaria e di bilancio.
Secondo Hayek, la responsabilità dell’inflazione mondiale degli anni 70 era della teoria di Keynes.
Era stato per consiglio dei keynesiani che i governi avevano finanziato una crescente frazione delle loro spese creando moneta.
Questo cattivo consiglio era stato dato nella convinzione che ogni disoccupazione consistente è dovuta ad un’insufficienza della domanda aggregata ed è ovviabile con un aumento di questa.
Hayek: “è vero che parte dell’occupazione è dovuta a questo e che un aumento nella domanda aggregata porta ad un temporaneo aumento dell’occupazione, ma non è vero che tutta la disoccupazione è dovuta ad insufficienza della domanda totale, e parte dell’occupazione creata all’inizio dall’aumento della domanda aggregata non potrebbe essere mantenuta se la domanda resta al livello raggiunto, ma solo con un continuo aumento di questa, come la teoria accelerazionista ha dimostrato.
Un’altra convinzione sbagliata è, secondo Hayek, che l’unica conseguenza dell’inflazione sia una redistribuzione dei redditi, mentre la disoccupazione significa riduzione del reddito reale complessivo.
Il processo inflazionistico, secondo Hayek, mina la struttura dell’economia alle fondamenta e le dà un carattere distorto che provoca più disoccupazione di quella che si voleva evitare.
Hayek: “un numero sempre più vasto di lavoratori viene attirato in impieghi che dipendono da un’inflazione in continua ascesa.
Il risultato è instabilità più ampia dell’occupazione si troverà a dipendere dal processo inflazionistico”.
Questa disoccupazione che dipende dall’inflazione, può essere curata con lo spostamento dei lavoratori dai settori con eccesso d’offerta ai settori che ne sono carenti.
Hayek condivide l’affermazione di Friedman che l’inflazione è dovuta ad un eccesso della domanda.
“I sindacati possono far pressione su un governo impegnato in una politica keynesiana di pieno impiego perché crei inflazione per impedire la disoccupazione che la loro azione potrebbe altrimenti causare”.
Secondo Hayek esiste un ruolo dei sindacati nella creazione dell’inflazione, anche se assume rilievo solo quando il governo è impegnato in una politica di difesa dell’occupazione.
Hayek non condivide l’idea di Friedman che l’indicizzazione sia raccomandabile per contrastare l’inflazione.
L’indicizzazione non rimuove la causa vera dell’inflazione, che è il tentativo della gente di comperare più di quanto ci sia sul mercato e la sua insistenza perché le venga dato abbastanza denaro da permetterle di comperare ai prezzi correnti quel che desidera procurarsi.
Il circolo vizioso può rompersi solo se ci si accontenta di un potere d’acquisto reale più basso di quello che è stato inseguito.
L’indicizzazione potrebbe rendere inevitabile un’inflazione.
Il pensiero monetarista è utile nella distribuzione del tradeoff, ma meno utile perché ripropone il ritorno agli schemi classici.
Friedman diche che dopo un po’ di tempo che c’è una politica economica espansiva gli operatori si adattano al comportamento delle autorità economiche e comprendono che solo i prezzi salgono e la disoccupazione torna al livello precedente.