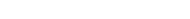Il prelievo obbligatorio è la necessità di far pagare tutti i cittadini prescindendo dal consumo effettivo di servizi pubblici e dalle loro preferenze personali.
E’ con la leva dei tributi che le democrazie finanziano le due funzioni principali degli stati che le contraddistinguono e cioè l’erogazione dei servizi essenziali e la redistribuzione del reddito.
E’ con il voto che i cittadini possono esprimere la propria scelta sul prelievo obbligatorio.
La pressione fiscale è alla base della democrazia economica che pone alla propria base il diritto ad una condizione economica e sociale del cittadino dignitoso, a migliorare la propria condizione, a controllare i mezzi di produzione e quello alla sovranità economica nel territorio in cui si vive.
La politica tributaria concilia le funzioni di allocazione, redistribuzione e stabilizzazione imponendo rispetto a queste funzioni un confronto tra efficienza ed equità.
I prelievi obbligatori sono coattivi che la pubblica amministrazione fa nei confronti dei cittadini secondo principi tracciati dalla Corte Costituzionale e necessari per finanziare la spesa pubblica.
Essi sono classificabili a seconda dei percettori (amministrazioni centrali, locali e di sicurezza sociale), a seconda della base imponibile (reddito, consumo, patrimonio), a seconda dell’importo sul quale è calcolato il prelievo e della struttura delle aliquote di prelievo (progressivi, proporzionali).
Le imposte, le tasse e i contributi sociali derivano da un preciso obbligo sancito dalla legge, l’obbligo di versare le tasse deriva da un preciso rapporto giuridico contributivo.
Le imposte sono tributi senza contropartita specifica, le tasse sono prestazioni di un servizio alle persone che coprono solo parzialmente il costo, i contributi sociali sono prelievi obbligatori ed in alcuni casi facoltativi versati a organismi pubblici e privati per l’erogazione di prestazioni e sono commisurate ai salari che gravano sui datori di lavoro.
La tassazione è progressiva se la somma pagata aumenta all’aumentare della base imponibile; è proporzionale se il rapporto non varia con la base imponibile.
Annualmente con la legge di bilancio e con un voto parlamentare, in relazione al volume della spesa pubblica previsto si definisce la base imponibile ed il livello della pressione tributaria cioè il livello dell’incidenza sui redditi determinato dal livello delle aliquote.
Obiettivi della politica tributaria: acquisire le risorse necessarie per soddisfare i bisogni pubblici, correggere inefficienze economiche ed intervenire sulla distribuzione del reddito.
La politica tributaria interferisce con le tre funzioni della politica economica (allocazione, distribuzione, stabilizzazione).
Con la tassazione è possibile modificare i prezzi relativi di beni e servizi e tra fattori della produzione.
La tassazione non è neutrale e può provocare distorsioni fiscali.
Ad es l’imposta sul reddito incide cambiando i termini della scelta tra lavoro e tempo libero; un’imposta sui prodotti di importazione determina un rincaro rispetto ai prodotti locali e riorienta produzione e consumi.
L’imposta si fonda su un presupposto, su un fatto giuridico dal quale in modo diretto o indiretto deriva l’obbligo tributario.
Vanno poi individuate la base imponibile e l’aliquota di applicazione.
L’imposta a somma fissa sui beni e servizi (imposta capitaria) dove tutti i contribuenti pagano in modo uguale e lo stesso non può trasferire né usufruire sull’ammontare del trasferimento con una modifica del proprio comportamento.
Le imposte a somma fissa sono criticabili in quanto derogano al principio della contribuzione secondo le possibilità reali del contribuente.
L’imposizione consente di correggere esternalità e distorsioni nel mercato come l’inquinamento dell’aria, ma consente anche il finanziamento di beni pubblici non prodotti dal mercato.
La tassazione agisce sulla distribuzione del reddito e può svolgere un ruolo di protezione sociale, può avere effetti intragenerazionali redistribuendo redditi tra le categorie e effetti intergenerazionali, ma interviene anche nella distribuzione dei redditi tra capitale e lavoro.
La tassazione può intervenire nella stabilizzazione dell’economia: se la tassazione aumenta in fase di ripresa, frena la domanda e l’inflazione; se diminuisce in fase di rallentamento dell’economia, può sostenere la domanda.
La politica tributaria non è neutrale rispetto allo sviluppo dell’economia e intervenendo in modo inadeguato può incidere sul ciclo economico.
Le tre funzioni di allocazione, distribuzione e stabilizzazione possono essere compresenti, per esempio l’imposta capitaria elimina le distorsioni ma pesa sui meno abbienti; l’imposta progressiva pesa di più sugli abbienti e redistribuisce ma riduce l’incentivo al lavoro e l’efficienza economica.
Tema centrale nello studio delle politiche tributarie è la pressione fiscale.
Talvolta si fa riferimento anche alla pressione finanziaria quando si considerano gli elementi della pressione tributaria + gli altri proventi pubblici quali imposte e contributi + prezzi, tariffe e canoni.
Annualmente si parla di pressione tributaria quale rapporto tra l’insieme delle imposte dirette e indirette percepite dallo Stato rispetto al PIL, ma forse un’indicazione più precisa si ha con la pressione fiscale sull’economia che è il costo dello Stato, un rapporto che esprime l’incidenza del totale delle imposte e dei contributi sociali effettivi e figurativi (gettito fiscale + contributi previdenziali) rispetto al PIL.
I rapporti indicati non forniscono indicazione sulla qualità e quantità dei servizi pubblici forniti a fronte dei tributi.
Si ha una tendenza per molti paesi all’aumento della pressione fiscale ed una differenza del livello di pressione fiscale.
In Eu la tassazione maggiore si ha nei paesi scandinavi, mentre è minore nei paesi anglosassoni con una fiscalità molto impegnata a sostenere l’istruzione, la sanità pubblica e i servizi sociali.
In Italia le spese per la protezione sociale (vecchiaia, sanità, famiglia, disoccupazione) assorbono più di un terzo del bilancio degli enti pubblici.
I problemi sulla costruzione di indici di misura della pressione tributaria fanno riferimento alla necessità di disporre di un indicatore dal sacrificio imposto nella rinuncia all’uso di risorse private per effetto del prelievo, e al fatto che gli indici non fanno normalmente riferimento a gruppi sociali omogenei di contribuenti.
Questi indici non tengono conto degli effetti di traslazione delle imposte che debbono essere misurati con altri strumenti.
Normalmente imposta e tassa sono considerati sinonimi.
L’imposta è l’onere che lo Stato impone al cittadino contribuente senza un nesso specifico ad attività svolte dallo Stato o da altri enti pubblici.
Le imposte di scopo sono quelle il cui gettito è destinato a finanziare una specifica attività dello Stato non rispondendo al generico obiettivo di approvvigionamento di risorse, ma per esempio per finanziarie la costruzione di una scuola o il sostegno alle comunità colpite da calamità naturali.
Talvolta sono denominate imposte extra-fiscali, sono ad es l’addizionale sulle accise dei carburanti.
Le imposte generali finanziano servizi generali, come l’imposta sul reddito o sugli utili delle società.
Accanto al gettito derivante delle entrate fiscali una parte delle spese pubbliche viene finanziata da entrate non tributarie come i proventi e dividendi delle imprese pubbliche, il ricavato delle privatizzazioni e di cespiti patrimoniali, i proventi delle vendite di beni e di servizi e le pene pecuniarie (queste sono entrate non fiscali).
La suddivisione delle imposte può essere fatta con riferimento ai differenti livelli dei soggetti e delle amministrazioni che percepiscono l’imposta.
L’imposizione può fare riferimento all’impiego o alla titolarità di fattori della produzione, allo scambio o al consumo di beni o servizi, al compimento di atti giudiziari.
– L’ imposizione diretta interviene sulla capacità contributiva immediata dei soggetti.
Es. imposta sul reddito che tiene conto del valore della famiglia, imposte sul patrimonio, sulle società, imposte locali sulla produzione come IRAP, contributi sociali a carico dei datori e dei lavoratori.
L’imposta diretta è personalizzabile, fa riferimento alla situazione reddituale personale del contribuente.
– L’imposta indiretta colpisce la manifestazione della capacità di reddito di un soggetto, come i consumi, gli scambi ed i trasferimenti.
È correlata al valore delle transazioni o certificazioni oggetto degli atti o al prezzo dei beni o servizi scambiati ( imposte ad valorem), o alla quantità di beni o servizi scambiati ( imposte specifiche), ma può essere determinata anche indipendentemente da elementi quantitativi o di valore, come nelle imposte fisse.
Vi sono poi le accise sulla benzina, alcolici e tabacco in relazione alla quantità consumata.
Diminuiscono il rischio di evasione fiscale, sono flessibili perché possono essere variate rapidamente secondo le esigenze della politica economica e non scoraggiano gli investimenti, come invece accade nel caso delle imposte dirette.
Svantaggio: possono essere trasferite dal contribuente di diritto a quello di fatto.
Circa l’incidenza rispetto alla base imponibile le imposte possono essere proporzionali, progressive o regressive, sia con riferimento al reddito del singolo contribuente che con riferimento all’intero sistema tributario.
L’analisi dell’evoluzione dei sistemi di sicurezza sociali fa riferimento a due categorie: sistemi di imposizione bismarckiano (Germania, Austria, Francia Svezia, Olanda, qui dato che i trasferimenti sociali sono redditi differiti occorre che i lavoratori che ne godranno i benefici contribuiscano al loro finanziamento) e sistemi beveridgiano (Regno Unito, Italia, Danimarca, Irlanda; è alla base della riforma dello stato sociale relativo a tutte le questioni della sicurezza sociale e dei servizi connessi e occorre garantire anche ai meno abbienti l’accesso ai servizi essenziali) con riferimento ai trasferimenti sociali.
Categorie degli agenti economici chiamati al pagamento delle imposte: individuo, famiglie e imprese.
Nei Paesi Scandinavi e Gran Bretagna prevalgono imposte dirette mentre Francia, Svezia, Germania si fondano su contributi sociali.
Uno degli obiettivi d’indagine nelle scienze delle finanze è la misura dell’impatto redistributivo delle imposte, analisi fondata sul confronto della distribuzione dei redditi antecedente e susseguente all’introduzione di un’imposta.
Accanto agli effetti dell’imposizione occorre tener conto di trasferimenti sociali, aiuti al reddito, sussidi erogati dall’operatore pubblico a sostegno di politiche dallo stesso poste come obiettivo.
Nella valutazione del carico tributario agli effetti della redistribuzione occorre tener conto di: Reddito primario (prodotto dall’attività economica o dal possesso di beni mobili e immobili); Reddito iniziale (depurato dai contributi sociali); Reddito disponibile (decurtazione delle imposte dirette dal reddito iniziale); Reddito netto (aggiunta delle prestazioni sociali al reddito disponibile); Reddito finale (reddito netto decurtato dalle imposte indirette).
Nella valutazione occorre far riferimento alle unità di consumo e la redistribuzione può far riferimento a livelli di reddito (verticale) o categorie di soggetti (orizzontale).
Una delle ottiche con cui guardare l’azione di redistribuzione del reddito per finalità di politica economica è di non scoraggiare il lavoro e l’impegno rivolto all’acquisizione di un reddito più alto.
L’indicatore adeguato per misurare l’incentivo all’impiego è l’aliquota marginale di imposta che misura il rapporto tra l’incremento dell’imposta e l’incremento dell’imponibile, uno strumento impiegato per valutare gli effetti di incentivo o disincentivo dell’imposta alla produzione del reddito.