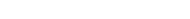Tutte le politiche economiche (monetaria, fiscale, del lavoro, dell’offerta, della competitività, energetica) creano le condizioni perché si possa raggiungere la disoccupazione naturale (quella connaturale ad una certa economia).
Secondo i neoclassici per aumentare l’occupazione bisogna diminuire il salario reale, è quest’ultimo a determinare livello della produzione globale, c’è sempre un tasso di interesse che bilancia risparmio e investimento; secondo Keynes è la domanda effettiva a determinare l’occupazione e per aumentarla servono politiche di sostegno alla domanda.
Nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è previsto, all’art.
23 che: “Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione… ad eguale retribuzione per eguale lavoro…ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e famiglia un’esistenza dignitosa ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale…ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.” Quando sindacati e lavoratori si oppongono alla diminuzione dei salari nominali, si può comunque raggiungere la riduzione dei salari reali con un aumento dei prezzi delle merci vendute.
Primario obiettivo di politica economica è l’obiettivo occupazionale e può essere un obiettivo condivisibile.
La politica monetaria non è in grado di consentirne il raggiungimento, così come la politica fiscale.
La domanda dei fattori della produzione (capitale e lavoro) è, nella teoria neoclassica, una
domanda derivata: la domanda di lavoro e di capitale è derivata dalla
domanda dei beni, per la cui produzione sono utilizzati quei fattori.
La teoria neoclassica commette un errore fondamentale perché non distingue il caso dell’impresa singola da quello di un settore industriale e dell’economia nel complesso.
La teoria neoclassica dell’occupazione da un punto di vista macroeconomico può essere rappresentata come a fianco.
E’ il livello di occupazione d’equilibrio che assicura la produzione globale e questa viene sempre assorbita sul mercato perché esiste sempre un tasso di interesse che
mette in equilibrio risparmio e investimento, per cui la parte di reddito non spesa viene investita e il sistema economico è in equilibrio.
A seconda dell’occupazione raggiunta c’è una corrispondente produzione che viene assorbita dal sistema.
L’equilibrio sul mercato del lavoro viene raggiunto perché i salari reali sono flessibili.
L’unica legge di cui tener conto è la legge della produttività marginale decrescente (produttività dell’ultima ora lavorata), per cui gli imprenditori assumeranno lavoratori finchè il salario sarà uguale alla produttività marginale decrescente.
Questo schema dimentica un aspetto essenziale del funzionamento del sistema economico: i consumi non derivano sono dall’equilibrio sul mercato del risparmio, ma anche dal reddito globale della comunità.
Per aumentare l’occupazione per i neoclassici quindi i lavoratori devono accettare salari reali più bassi.
Una riduzione generale del salario reale ha effetti sulla domanda effettiva e sui consumi globali.
Occorre distinguere gli effetti della riduzione del salario d’interesse nel caso di un’impresa singola, un settore industriale e l’economia nel complesso.
NEOCLASSICI
– caso dell’impresa singola.
Nel modello neoclassico sono la scelta del livello della produzione e quella della tecnica di produzione a determinare la domanda di lavoro dell’impresa.
L’impresa non domanda lavoro solo in base all’andamento del mercato dei beni in cui opera, ma anche secondo il prezzo relativo dei fattori della produzione.
Questo è vero alla nascita dell’impresa.
È il primo principio della domanda dei fattori della produzione: stabilisce che l’impresa utilizza processi produttivi con una sempre maggiore intensità di capitale all’aumentare del costo relativo del lavoro.
Questo principio ci permette di comprendere perché esistano grandi differenze nei rapporti capitale lavoro utilizzati tra Paesi diversi negli stessi settori industriali.
Più è alto il rapporto salario- rendimento del capitale, più sarà alto il rapporto capitale-lavoro.
Questo principio è indiscutibile per spiegare la scelta della tecnica di produzione quando nasce un’impresa, ma non è valido quando gli impianti esistono già e sopravvengono delle variazioni nel rapporto salario-rendimento del capitale.
Capitale e lavoro sono sostituibili se una data variazione nel rapporto salario-rendimento del capitale provoca una grande variazione nel rapporto capitale-lavoro.
Se l’impresa non muta il rapporto capitale-lavoro quando si verificano grandi variazioni nel rapporto salario-rendimento del capitale, diciamo che capitale e lavoro non sono facilmente sostituibili tra loro: l’impresa deve mantenere la stessa tecnica di produzione anche quando cambiano i prezzi relativi dei fattori.
La sostituzione è semplice nel lungo periodo, in una piccola industria piuttosto che in un grande impianto industriale.
Nel breve periodo possiamo dire che lo stock di capitale dell’impresa è fisso.
L’impresa impiegherà lavoro aggiunto solo se il beneficio che trarrà da ciò sarà maggiore o uguale al costo del maggiore lavoro espresso dal salario monetario, che per la singola impresa, è un dato.
Il contributo di un’ora addizionale è inferiore a quello dell’ora precedente e, dato il capitale, il lavoro offre un prodotto marginale decrescente.
Anche il prodotto marginale in valore (prodotto marginale * prezzi) ha una funzione decrescente, perché le imprese operano in concorrenza perfetta e non possono influenzare, prese singolarmente, i prezzi a cui riusciranno a vendere i prodotti.
Il salario monetario è invece uniforme: l’impresa per la prima ora di lavoro paga quanto paga per l’ultima.
Qui, se l’impresa intende massimizzare i suoi profitti, domanderà lavoro fino a quando il salario è uguale al prodotto marginale in valore, ovvero fino a quando il salario reale sarà uguale al prodotto marginale in termini fisici.
Primo postulato fondamentale della teoria neoclassica dell’occupazione: Il salario è uguale al valore del prodotto marginale del lavoro.
Occorre chiedersi come varia la quantità di lavoro domandata dall’impresa quando c’è un mutamento nel salario o un cambiamento nella produttività del lavoro.
Un aumento del salario, dati i prezzi dei prodotti dell’impresa, riduce l’occupazione, la cui diminuzione dipende dalla pendenza della curva della produttività marginale decrescente, che dipende dalla misura in cui capitale e lavoro sono sostituibili nella produzione: se sono altamente sostituibili.
Nel breve periodo la capacità di variare le tecniche adottate di produzione è modesta.
A salario costante, quale sia l’effetto di un aumento del prezzo del prodotto implica che, per ogni livello di produzione, il valore del prodotto marginale è aumentato.
La curva del valore del prodotto marginale si sposta a destra verso l’alto e, al livello di salario precedente l’aumento del prezzo del prodotto, l’impresa trova conveniente espandere l’occupazione.
Come in figura, la diminuzione del salario reale comporta un aumento dell’occupazione presso quella singola impresa.
Quando la riduzione del salario reale è limitata alla singola impresa, si avrà un effetto positivo sull’occupazione presso l’impresa perché la riduzione del salario reale non determinerà una diminuzione del prezzo di equilibrio del prodotto.
La curva di domanda del lavoro rimane costante e la diminuzione del salario reale da (W/P)0 a (W/P)1 comporta l’aumento dell’occupazione da 1000 persone a 1500.
La domanda di lavoro dell’impresa, secondo i neoclassici, è funzione del salario reale, il salario che essa paga in moneta diviso il prezzo del suo prodotto.
Una riduzione del salario reale avrà un effetto positivo sull’occupazione nell’impresa perché non determinerà una diminuzione del prezzo di equilibrio del prodotto.
– caso del settore industriale.
Se il salario reale diminuisce in tutte le imprese di un settore, aumentano l’occupazione
e la produzione complessiva del settore.
Se nel frattempo non varia la domanda dei beni del settore, il prezzo di equilibrio scenderà, perché una maggiore offerta di beni sarà accolta dal mercato solo con una diminuzione del prezzo di quei beni.
Al nuovo prezzo di equilibrio il valore della produzione marginale sarà minore: la curva della produttività marginale in valore, per ogni impresa, si sposterà a sinistra.
La curva VPML0 è la somma orizzontale delle curve del valore del prodotto marginale delle imprese di un settore industriale.
Tale curva è tracciata per un dato prezzo del prodotto.
Quando il salario diminuisce da (W/P)0 a (W/P)1, tutte le imprese del settore espandono l’occupazione e la produzione portano l’occupazione vicino al valore atteso sulla VPML0.
Dal momento che cresce la produzione del settore, i beni prodotti saranno assorbiti dal
mercato ad un prezzo minore, quindi la produttività marginale diminuisce e si sposta a sinistra (VPML1), che è la stessa produttività marginale fisica per il nuovo valore monetario dei beni registrato sul mercato.
Il punto di equilibrio permanente non sarà E1 come atteso da ogni imprenditore, ma E’1.
L’occupazione crescerà poco rispetto al punto di partenza (sull’asse delle ascisse il punto E) e corrisponderà alla proiezione sull’asse delle ascisse del vero punto di equilibrio permanente E’1.
Per ottenere la domanda di lavoro del settore industriale occorre unire E0 e E’1.
Emerge che è molto più verticale dell’originaria VPML0, perché deve registrare il ridotto valore della produttività marginale registratosi in seguito all’abbassamento dei prezzi prodotto nel sistema dall’aumento di beni prodotti.
L’aumento dell’occupazione non sarà dunque quello atteso dal singolo imprenditore lungo l’originaria curva della produttività marginale decrescente, ma si troverà sulla nuova curva, inferiore alla precedente.
Unendo i punti di equilibrio sulle curve della produttività marginale otterremo la curva della domanda di lavoro del settore più verticale delle sottostanti.
L’elasticità della domanda di lavoro di un settore industriale determinata dalla sostituibilità capitale-lavoro nella produzione che nel breve periodo è scarsa e dall’elasticità della domanda dei beni del settore.
Se la domanda per i beni prodotti dal settore è molto elastica, un incremento dell’offerta dei beni non avrà effetto sul prezzo di vendita dei beni; se invece la curva della domanda dei beni è inelastica, un incremento dell’offerta dei beni provocherà una diminuzione del prezzo consistente, che diminuirà il valore della produttività marginale del lavoro del settore.
Questa relazione tra l’elasticità della domanda del bene e l’elasticità della domanda di lavoro riflette la condizione di partenza neoclassica: la domanda dei fattori della produzione è una domanda derivata.
– La domanda di lavoro globale.
La diminuzione del salario reale è estesa a tutte le imprese di un settore e se è accompagnata da una domanda inelastica dei beni di quel settore (domanda cioè incapace di evitare una diminuzione del prezzo d’equilibrio del bene prodotto).
Quando la diminuzione dei salari reali non si limita a un solo settore industriale, ma avviene in tutte le industrie questo accrescerà la produzione globale.
Ogni settore industriale subirà la concorrenza degli altri, tutti aumenteranno
contemporaneamente l’offerta di prodotti.
Ogni impresa subirà la concorrenza delle imprese operanti nello stesso settore, ma anche quella derivante dalla maggiore produzione globale.
Se il salario reale si riduce per tutti i settori e la produzione dell’assieme cresce, i prezzi scenderanno per i beni.
Ai nuovi prezzi d’equilibrio dei beni, i valori delle produzioni marginali decrescenti dei settori industriali saranno minori: le domande di lavoro dei settori industriali si sposteranno a sinistra.
L’aumento dell’occupazione non sarà quello atteso in ogni settore industriale, lungo l’originaria curva della
domanda del settore industriale, ma si troverà sulla nuova curva della domanda del settore, di valore inferiore alla precedente.
Unendo i punti di equilibrio sulle curve dei valori della produttività marginale decrescente delle industrie, si attenua la curva della domanda di lavoro globale caratterizzata da un’elevata pendenza e potrebbe essere proprio verticale.
La domanda di lavoro di un settore industriale, quella globale di un Paese possono avere la stessa elasticità della domanda di lavoro di un’impresa, se le domande dei beni dei singoli settori industriali sono elastiche, così da evitare una caduta dei prezzi di equilibrio dei settori.
Questa elasticità elevata dei settori implica che il consumo totale aumenti.
Una diminuzione del salario reale porta ad un consumo maggiore solo in certe condizioni.
La diminuzione del salario reale accrescerà in un primo momento l’occupazione.
Si potrebbe verificare un aumento dell’occupazione tale da compensare la diminuzione dei salari e capace di alimentare tutto il processo: aumentare il consumo globale e consentire elasticità alle domande dei beni.
Alcuni ritengono che questo è quanto accadrà in seguito ad una riduzione del salario reale.
La riduzione dei salari reali incentiva la produzione delle imprese perché accresce i profitti attesi e comporta una redistribuzione del reddito globale dai salariati agli imprenditori: questi hanno una più bassa propensione al consumo rispetto ai salariati.
È poco probabile un aumento del consumo, ma anzi può verificarsi un aumento del risparmio, con conseguente depressione della domanda aggregata, a meno che non intervenga una maggiore spesa per investimenti a compensare il vuoto di domanda così creatosi.
È difficile pensare che gli imprenditori aumenteranno la spesa per investimenti quando il loro ricavo non giungerebbe a coprire il loro prezzo di offerta e saranno chiamati ad effettuare tagli rispetto all’occupazione attesa.
Il processo che abbiamo descritto sulla verticalizzazione della domanda globale di lavoro è la figura a lato.
DL è la somma orizzontale delle curve del valore del prodotto marginale dei settori industriali.
Questa curva è tracciata per dati prezzi d’equilibrio.
Quando il salario reale si riduce per tutti i settori e la produzione di questi cresce, i prezzi scenderanno per i beni.
Ai nuovi prezzi d’equilibrio dei beni, i valori delle produzioni marginali decrescenti dei singoli settori si sposteranno a sinistra.
DL1 è la nuova somma delle domande di lavoro dei settori industriali.
In seguito ad una diminuzione del salario dal (W/p)0 a (W/P)1, l’aumento dell’occupazione non sarà quello atteso nel punto di equilibrio E1, pari alla proiezione sull’asse delle ascisse del punto di incontro tra DL e il nuovo salario reale.
Il nuovo punto di equilibrio sarà su DL1 e sarà E’1.
Unendo i punti di equilibrio sulle curve di domanda di lavoro della somma dei settori, otterremo la curva della domanda di lavoro globale.
Nel disegno la curva di domanda di lavoro globale è quasi verticale, quindi la riduzione del salario reale non ha prodotto gli effetti occupazionali attesi.
Gli effetti di una variazione del salario reale sulla domanda globale di lavoro dipendono da due variabili: dalla capacità produttiva del sistema; dalle reazioni dei clienti sul mercato dei beni.
Se il salario reale si riduce per tutte le imprese, la conseguenza è che si riduca la domanda complessiva di beni, e quindi la domanda di ogni impresa.
L’errore della teoria neoclassica dell’occupazione è non aver considerato la ricaduta sulla domanda globale della riduzione del salario, quando esso è generalizzato all’intero sistema economico.
KEYNES “Nel mettere in evidenza il nostro distacco dal sistema classico, non dobbiamo trascurare un punto di accordo.
Sosteniamo come per il primo postulato (il salario è uguale al prodotto marginale del lavoro) con le limitazioni della teoria classica, significa che, in un’organizzazione e con una data
quantità di beni capitali e una data tecnica, salari reali e il volume della produzione (e quindi dell’occupazione) sono biunivocamente connessi; in generale non può verificarsi un aumento dell’occupazione se non insieme con una discesa del saggio dei salari reali.
Quindi non metto in dubbio questo fatto essenziale, che i classici hanno dichiarato incontrovertibile.
In una data situazione dell’organizzazione, dell’attrezzatura e della tecnica, il salario reale guadagnato dall’unità lavorativa ha una correlazione univoca, e inversa, col volume dell’occupazione.
In periodi brevi, se l’occupazione aumenta, la remunerazione unitaria del lavoro in termini di merci-salario deve diminuire e i profitti aumentare.
Questo è l’inverso della comune proposizione che l’industria lavora normalmente in regime di produttività decrescente in periodi brevi nei quali l’attrezzatura sia supposta costante; cosicché il prodotto marginale nelle industrie producenti merci salario (il quale governa i salari reali) diminuisce col crescere dell’occupazione.
Fin quando vale tale proposizione, qualsiasi modo di aumentare l’occupazione deve condurre nello stesso tempo ad una diminuzione del prodotto marginale, quindi del saggio dei salari misurato o in termini di questo prodotto.
Siccome abbiamo respinto il secondo postulato, una diminuzione dell’occupazione, benché comporti che i lavoratori ricevano un salario equivalente ad una maggiore quantità di merci salario, non è dovuta per forza al fatto che i lavoratori domandino più quantità di merci-salario; e l’essere i lavoratori disposti ad accettare una riduzione dei salari monetari non è per forza un rimedio alla disoccupazione”.
Dice Keynes, che non ha mai negato la validità della legge della produttività marginale decrescente.
Il punto di distacco rispetto alla precedente teoria economica è il rifiuto della legge di Say e del secondo postulato dell’economia classica “L’utilità del salario, per un dato ammontare di lavoro occupato, è uguale alla disutilità marginale di quell’ammontare di occupazione”, cioè il rifiuto dell’idea “che i contratti di salario fra imprenditori e lavoratori determinano il salario reale; e supponendo libera concorrenza fra imprenditori e nessuna coalizione restrittiva fra i lavoratori, questi, se lo desiderano, possono portare i propri salari reali a coincidere con la disutilità marginale di quel volume di occupazione che è offerto dagli imprenditori a quel salario”.
Il rifiuto del secondo postulato determina il rifiuto della concezione classica del mercato del lavoro: non è sul mercato del lavoro, nell’incontro della domanda e dell’offerta che si determinano, secondo Keynes, il livello di occupazione e di produzione.
E’ il livello della domanda effettiva che determina occupazione e produzione.
Il salario reale determina l’occupazione perché una volta determinata la produzione di equilibrio, dev’esser prodotta tenendo conto della curva del valore del prodotto marginale.
Keynes sostiene che il livello di occupazione e di produzione è determinato dall’intersezione di due funzioni del livello di occupazione: la domanda aggregata D=D(N) e l’offerta aggregata Z=Z(N).
Z è il ricavo ottenibile dalla vendita del prodotto associato a ciascun livello di occupazione, che indurrebbe le imprese a spingere l’occupazione fino a quel livello.
La curva d’offerta aggregata indica le combinazioni dei livelli della produzione e dell’occupazione che è conveniente per le imprese offrire; ovvero quali profitti è necessario che le imprese ottengano per spingere l’occupazione fino ad un certo punto.
Questa curva è inclinata positivamente.
La forma della Z è spiegata dall’ipotesi che il costo unitario cresce al crescere dell’occupazione.
Per ogni valore del salario monetario avremo una diversa curva Z, poiché al variare del salario monetario variano i costi monetari di produzione.
La funzione della domanda aggregata D è il ricavo atteso dalle imprese per la vendita del prodotto associato a ciascun livello di occupazione.
Per ipotesi questo ricavo atteso è anche realizzato.
In un’economia chiusa e senza tener conto dello Stato, la curva della domanda aggregata è la domanda di beni di consumo e d’investimento.
Anche questa curva cresce al crescere dell’occupazione, ma meno di quanto cresca l’offerta aggregata.
Secondo Keynes le spese per consumi crescono all’aumentare del reddito dei lavoratori, ma meno di quanto cresca il reddito.
Se Z è il prezzo dell’offerta complessiva della quantità di prodotto derivante dall’occupazione di N lavoratori, la relazione fra Z e N è la funzione Z =z(N), funzione di offerta complessiva.
Se D è il ricavo che gli imprenditori prevedono di conseguire con l’occupazione di N lavoratori, la relazione fra D e N sarà la funzione D=d(N), funzione di domanda complessiva.
Se per un dato valore di N il ricavo previsto è maggiore del prezzo dell’offerta complessiva, ossia se D>Z, vi sarà un incentivo per gli imprenditori ad aumentare l’occupazione oltre N, e ad accrescere i costi entrando in concorrenza fra loro per assicurarsi i fattori di produzione, fino a quel valore di N per il quale Z=D.
Quindi il volume di occupazione è dato dal punto di intersezione fra la funzione di domanda e offerta complessiva, giacché a quel punto saranno rese massime le previsioni di profitti dagli imprenditori.
Chiameremo domanda effettiva il valore di D nel punto della funzione di domanda complessiva nel quale questa è intersecata dalla funzione di offerta complessiva.
La quantità di lavoratori N che gli imprenditori decidono di occupare dipende dalla somma (D) di due quantità, la spesa prevedibile della collettività in consumi e il prevedibile ammontare che essa destinerà a nuovi investimenti.
Poiché il consumo dipende dalla propensione a consumare, l’occupazione in condizioni di equilibrio dipende: dalla funzione di offerta complessiva; dalla propensione a consumare, dal volume dell’investimento.
Keynes afferma che: “Per ogni N esiste una corrispondente produttività marginale del lavoro nelle industrie producenti merci-salario; ed è questa che determina il salario reale.” “(…) la propensione a consumare e la quota dei nuovi investimenti determinano il volume dell’occupazione, che corrisponde ad un dato livello di salari reali; ma queste relazioni sono irreversibili”.
Nello schema Keynesiano l’identità tra il salario e il valore della produzione serve solo a specificare il livello di salario reale “associato con ogni livello di occupazione di equilibrio determinato dalla domanda effettiva.” Questo ha una grande conseguenza perché vorrebbe dire che, una volta trovata l’occupazione occorre retrocedere sul mercato del lavoro per comprendere quale sia il salario reale compatibile con la piena occupazione.
La Teoria Generale fu considerata divisa in tre parti: .
1.la teoria del moltiplicatore;
2. l’efficienza marginale del capitale;
3.la preferenza per la liquidità.
Una volta individuata l’occupazione determinata dalla domanda effettiva, occorre retrocedere il valore trovato sulla curva della domanda globale del lavoro per verificare il salario reale d’equilibrio.
Un salario reale superiore a quello d’equilibrio determina una disoccupazione rispetto al livello d’occupazione determinato dalla domanda effettiva.
La domanda effettiva e la sua relazione con il salario reale riveste un ruolo principale nel pensiero di Keynes e apre le porte ad un’interpretazione più adeguata di tutte le altre parti della sua teoria.
In questo quadro la propensione a consumare, l’efficienza marginale del capitale, la preferenza per la liquidità, le variazioni del saggio d’interesse spiegano l’andamento della domanda effettiva, ma questa deve poi tener conto della legge della produttività marginale anche del lavoro e deve tenerne conto nel breve periodo.
L’esistenza di una stretta relazione tra la domanda effettiva e il salario reale è portatrice di conseguenze.
Se ad ogni livello della domanda effettiva corrisponde un solo valore del salario lungo la curva del valore della produttività marginale decrescente, allora ad ogni aumento della domanda effettiva e quindi della produzione e dell’occupazione deve corrispondere una diminuzione del salario reale.
La novità in Keynes è che questa diminuzione del salario reale non debba necessariamente avvenire con una riduzione del salario nominale, ma con un aumento dei prezzi, lasciando i salari nominali invariati.
“Siccome non vi è alcun mezzo di ridurre i salari monetari simultaneamente ed ugualmente tutte le industrie, è nell’interesse dei lavoratori di opporsi ad una riduzione nel proprio caso.
U un movimento dagli imprenditori allo scopo di rivedere i contratti di salario monetario incontrerà una resistenza più forte di un abbassamento automatico dei salari reali in conseguenza di un aumento dei prezzi.” “Ma se il presupposto classico non vale, sarà possibile aumentare l’occupazione accrescendo la spesa in termini di moneta fino a quando i salari reali saranno discesi al punto di eguaglianza con la disutilità marginale del lavoro.” Per Keynes è il livello d’occupazione determinato dalla domanda effettiva a determinare il salario reale d’equilibrio, mentre nella teoria neoclassica è il livello del salario reale d’equilibrio a determinare il livello d’occupazione d’equilibrio.
La differenza è un’inversione dell’ordine di causalità tra le due variabili.
L’elasticità dell’occupazione e della produzione Keynes era consapevole che il concetto di domanda effettiva complessiva non fosse sufficiente a spiegare esattamente il livello dell’occupazione e della produzione, dal momento che esistono diversi modi nei quali spendere un aumento di salario.
Introdusse il concetto dell’elasticità dell’occupazione e della produzione: l’elasticità dell’occupazione misura la variazione del numero delle unità lavorative occupate nell’industria alle variazioni del numero delle unità di salario che si prevede saranno spese nell’acquistare la produzione dell’industria; L’elasticità della produzione misura l’ammontare del quale la produzione di un’industria qualsiasi aumenta nell’unità di tempo quando una domanda effettiva maggiore in termini di unità salario viene diretta verso tale industria.
Keynes: “La misura nella quale i prezzi (in termini di unità-salario) saliranno, ossia la misura nella quale i salari reali scenderanno quando la spesa monetaria viene accresciuta, dipende dall’elasticità della produzione in rispondenza della spesa in termini di unità-salario”.
Questo è quanto accade ai prezzi.
Con riferimento all’occupazione, solo se la maggiore domanda è diretta verso prodotti con alta elasticità di occupazione, l’aumento complessivo dell’occupazione sarà considerevole.
Il moltiplicatore del reddito, isolatamente, non spiega gli effetti di un aumento della domanda effettiva sull’occupazione e sulla produzione.
“Quando la domanda effettiva è deficiente vi è una sotto-occupazione dei lavoratori, vi sono lavoratori disoccupati che sarebbero disposti a lavorare ad un salario reale inferiore a quello vigente.
Con l’aumentare della domanda effettiva, l’occupazione aumenta, sebbene ad un salario reale uguale o inferiore a quello vigente, finché arriva un punto nel quale non vi è alcuna eccedenza di lavoro disponibile al salario reale allora vigente; ossia non vi sono più lavoratori disponibili a meno che a partire da quel punto, i salari monetari aumentino più rapidamente dei prezzi.
Fino a questo punto il rendimento decrescente dell’applicazione di una quantità maggiore di lavoro ad una data consistenza di impianti è stato compensato dalla tacita accettazione, dai lavoratori, di salari reali discendenti.
Dopo questo punto, un’unità lavorativa richiederebbe per compenso l’equivalente di una maggior quantità di prodotto, mentre il rendimento dall’applicazione di un’unità ulteriore sarebbe una quantità di prodotto minore.
Le condizioni di equilibrio richiedono che i salari e i prezzi e i profitti, debbano salire nella stessa proporzione della spesa, lasciando invariata la posizione reale, compreso il volume della produzione e dell’occupazione.
Le teorie keynesiane si soffermarono a studiare l’ipotesi di ridurre il salario reale con un aumento dei prezzi.
A prescindere se fosse la domanda effettiva o il salario reale o entrambi a determinare l’occupazione, diventava determinante studiare come ridurre il salario senza trattative sindacali, cioè via aumento dei prezzi delle merci prodotte.
Il rapporto W/P diminuisce perché W rimane costante in termini di denaro-moneta, mentre il livello dei prezzi delle merci prodotte aumenta.
CONCLUSIONI: la teoria neoclassica dell’occupazione è incompleta perché omette di considerare il consumo funzione
anche del reddito complessivo della comunità, dipendente dai salari medi pagati in una comunità economica.
L’idea degli economisti classici e neoclassici di aumentare l’occupazione con una riduzione dei salari reali è inefficace quando estesa dalla singola impresa all’insieme dell’economia.
Keynes parte all’inverso dalla domanda effettiva e confronta il livello occupazionale raggiunto tra il ricavo ottenuto dalla vendita del prodotto (offerta aggregata) e il ricavo atteso dalle imprese per la vendita del prodotto (domanda
aggregata).
Il livello dell’occupazione così determinato si confronta con il salario reale vigente sul mercato.
Se è superiore a quello potenziale, la sua diminuzione avviene con un aumento dei prezzi dei prodotti venduti, di cui i lavoratori fanno fatica ad accorgersi inizialmente.
L’idea di aumentare l’occupazione grazie all’inflazione non si è mostrata nel tempo una buona idea.
Entrambe le teorie hanno una caratteristica comune: considerano il valore della produttività marginale del lavoro dipende sia dal livello dei
prezzi che dalla produttività.
La produttività è il rapporto tra la quantità di prodotto finale e le quantità di uno o più fattori della produzione (materia prima, lavoro, energia, capitale) utilizzati nel processo.
Un aumento di produttività è un risparmio di fattori della produzione impiegati nel processo in termini fisici (meno ore lavorate, meno materie prime impiegate, meno energia utilizzata) sia dovuto a progresso tecnico, miglioramento dell’efficienza produttiva ricollegabile ad economie di scala, riduzione della capacità produttiva inutilizzata o altro.
A livello settoriale, si usa come misura della produttività dell’industria il valore aggiunto per lavoratore o ora lavorata, che viene preferito alla produzione lorda settoriale perché la produttività calcolata sulla base della produzione lorda è influenzata dal livello di integrazione verticale delle imprese.
Secondo i neoclassici e Keynes, il lavoro ha una produttività marginale decrescente: il contributo di un’ora addizionale è inferiore a quello dell’ora precedente, quindi la produttività decresce all’aumentare delle ore a disposizione dell’imprenditore.
Lo stesso vale per il prodotto marginale in valore (prodotto marginale*prezzi).
Anche esso è una funzione decrescente, perché le imprese si trovano ad operare in regime di concorrenza perfetta e quindi non possono influenzare, singolarmente, i prezzi a cui riusciranno a vendere i loro prodotti.
Ma il valore del prodotto marginale dipende anche dall’organizzazione tecnica dell’impresa, dai brevetti e da altri fattori che definiscono la sua produttività.
L’innovazione tecnica, la specializzazione, nuove organizzazioni, nuovi processi produttivi, possono spostare a destra la curva del prodotto marginale in valore.
Questi incrementi del valore del prodotto marginale possono essere trasformati in nuovi posti di lavoro o in salari più alti.
La curva del Valore del prodotto marginale può spostarsi a destra senza aumento dei prezzi.
Nella figura si ha un incremento del valore del prodotto marginale dovuto ad un incremento della produttività reale.
Il singolo lavoratore produce più prodotto a parità di tempo e questo avviene in una singola impresa.
L’incremento del valore del prodotto marginale non è dipeso dall’incremento dei prezzi, perché qui abbiamo raffigurato il valore del prodotto marginale reale e non quello monetario: il valore del prodotto marginale è diviso per il livello dei prezzi.
La maggiore produttività reale si ha con uno spostamento a destra del valore del prodotto marginale reale.
Quando l’incremento della produttività è limitato alla singola impresa, questa ha la facoltà di decidere se mantenere gli stessi lavoratori e pagare loro uno stipendio più alto, o portare al massimo il suo processo di massimizzazione.
In tal caso impiegherà allo stesso stipendio di prima molti più lavoratori nel nuovo punto di equilibrio G, portando l’occupazione sull’asse delle ascisse da F a J, più che doppia rispetto alla precedente.
Se ci troviamo in un’economia chiusa ai rapporti con l’estero, qualora l’incremento fosse diffuso a livello di settore, il prezzo del bene scenderebbe e questo avrebbe un riflesso sul valore del prodotto marginale che renderebbe la curva del settore più verticale.
In caso di economia aperta c’è una differenza tra il caso in cui il valore del prodotto marginale cresce per un incremento della produttività reale o per una diminuzione del salario reale: solo nel primo caso il Paese è più competitivo e i suoi cittadini diventano più ricchi a livello internazionale.
Le politiche dell’occupazione dovrebbero approfondire la dinamica di crescita della produttività reale, le relazioni tra competitività del Paese e produttività della singola impresa e di un settore industriale.
La Politica economica studierebbe le conseguenze delle altre politiche economiche (monetaria, fiscale, competitività, energetica) sulla competitività del sistema e sulla produttività della singola impresa e sull’occupazione.
La politica keynesiana di controllo della domanda si diffuse e trovò con la New Economic negli Stati Uniti applicazione, malgrado la sua vulnerabilità sui prezzi.
Le ricerche mostrarono l’esistenza di uno scambio tra inflazione e disoccupazione che parve essere capace di far ottenere ottimi risultati in termini di politica occupazionale.
Gli avvenimenti degli anni ’70, la compresenza di inflazione e recessione mise in discussione le politiche economiche fino allora seguite ed aprì un dibattito economico.
Il punto centrale è comprendere se, in presenza di inflazione, abbiano senso o meno le politiche espansive della domanda, se abbiano qualche effetto sull’occupazione o, date le aspettative degli operatori economici esse non sostengano l’aumento generale dei prezzi.
Occorre comprendere se le aspettative inflazionistiche sono adattive o razionali.