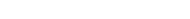Il collegio sindacale è un organo di controllo delle società che ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, e in alcuni casi esercita anche il controllo contabile. Il collegio sindacale è previsto dal codice civile ed è obbligatorio per le società di capitali di grandi dimensioni, così come per alcuni enti pubblici e privati.
Indice della guida
Chi lo compone
Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, chiamati sindaci. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere obbligatoriamente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I sindaci devono essere indipendenti: non possono avere rapporti di parentela con gli amministratori della società, né essere lavoratori o consulenti presso la stessa azienda. Sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo della società e successivamente dall’assemblea dei soci, restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
Track record delle operazioni
Vuoi sapere come decine di imprenditori hanno diminuito i costi e aumentando le performance e gli utili?
Scarica subito il track record delle operazioni
Compiti del collegio sindacale
I compiti del collegio sindacale sono descritti nell’articolo 2403 del codice civile e sono di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci. Inoltre, il collegio sindacale ha il potere di eseguire atti di ispezione e controllo, richiedere notizie e informazioni agli amministratori della società e convocare l’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi, potendo anche denunciare gli stessi amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.
Quali società devono dotarsene
Il collegio sindacale è obbligatorio per le società di capitali quali Spa (società per azioni) e Sapa (società in accomandita per azioni), mentre per le società a responsabilità limitata e le società in nome collettivo non è obbligatorio ma facoltativo. Tuttavia, con la legge 19 ottobre 2017, n° 155, anche le aziende meno dimensionate dovranno, a partire dall’approvazione del bilancio 2022, dotarsi di un collegio sindacale, anche se in questo caso potrà essere composto da un singolo membro.
Cosa manca alla tua azienda per prosperare?
Scopri subito attraverso il nostro veloce test cosa realmente manca a te e alla tua organizzazione per prosperare ed essere finalmente felici. Clicca sul pulsante inizia ora
Doveri
I doveri del collegio sindacale sono descritti nell’articolo 2403 del codice civile: essi devono vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, il collegio si deve riunire almeno una volta ogni 90 giorni e al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale contenente le deliberazioni dei sindaci.
I poteri
I poteri del collegio sindacale comprendono l’esecuzione di atti di ispezione e controllo, la richiesta di notizie e informazioni agli amministratori della società e la convocazione dell’assemblea dei soci in caso di mancata collaborazione degli amministratori o fatti molto gravi compiuti da questi. In casi estremi, il collegio sindacale può denunciare gli amministratori di fronte al tribunale per gravi inadempienze.
Requisiti di nomina
I requisiti di nomina per i membri del collegio sindacale sono: almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere obbligatoriamente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e i sindaci devono essere indipendenti, non possono avere rapporti di parentela con gli amministratori della società, né essere lavoratori o consulenti presso la stessa azienda.
Durata
La durata del mandato dei membri del collegio sindacale è di tre anni, e possono essere rieletti.
Dimissioni
Le dimissioni dei membri del collegio sindacale possono avvenire in qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla società.
Conclusioni
In sintesi, il collegio sindacale è un organo fondamentale per la tutela degli interessi dei soci e per la corretta gestione della società. Esso vigila sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, garantisce un controllo contabile adeguato e può intervenire in caso di mancata collaborazione o gravi inadempienze degli amministratori. Con la recente legge, anche le aziende meno dimensionate sono tenute a dotarsi di questo organo di controllo.