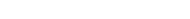La politica di intervento pubblico per l’ambiente si è evoluta nel tempo ed è rappresentabile in tre fasi:
– Politiche di “ comando e controllo” hanno istituito una rete di agenti che gestiscono il controllo delle norme fissate dall’autorità pubblica.
Questi strumenti sono associati ad attività di sanzionamento e fanno riferimento a valori diversi da quelli ottimali in senso economico.
Si definiscono comportamenti sottoposti ad azione di controllo pubblico.
– Piani di azione e incentivi di settore che hanno previsto strumenti economici e normativi rivolti alle imprese.
– Integrazione delle dimensioni ambientali e delle politiche nella programmazione dello sviluppo per orientarle dando concretezza alla realizzazione dello sviluppo sostenibile.
La produzione normativa a livello eu ha portato a metodologie di valutazione e di controllo integrale dell’inquinamento anche in relazione al maggior riconoscimento ai cittadini del diritto alle informazioni ambientale.
Oltre agli interventi di diffusione delle conoscenze e dell’informazione ambientale, la politica ambientale si fonda su strumenti per il controllo dell’inquinamento (incentivi economici e di comando e controllo).
Occorre menzionare gli strumenti economici volontari (codici di autoregolamentazione, analisi del ciclo di vita dei prodotti, audit ambientale, certificazione ambientale, etichettaggio ambientale, eco-budgeting, green procurement e cioè approvvigionamento pubblico di beni qualificati dal punto di vista ambientale).
La tassazione ambientale è il costo al quale è assoggettato chi genera inquinamento per ogni unità di inquinamento eguale al danno causato dalla determinazione dell’inquinamento ottimale.
La tassazione ambientale ha come obiettivo il raggiungimento di un livello ottimale di inquinamento con l’internalizzazione dei costi sociali dell’attività di produzione (correzione del sistema dei prezzi).
Si tratta di far ricadere sull’inquinatore in modo corretto il costo esterno dell’inquinamento, in modo che il mercato evolva verso un equilibrio socialmente sostenibile.
Così senza comportamenti coercitivi dall’amministrazione si controlla l’inquinamento in quanto le libere scelte di cittadini e imprese saranno influenzate dalla diversa struttura dei prezzi.
La tassa ambientale è determinata con la stima del danno monetario causato dall’attività inquinante ipotizzando una coincidenza tra danno e costo esterno.
È necessario conoscere le funzioni di danno monetario, ossia il valore del danno da inquinamento associato ad ogni livello di attività economica (e al relativo livello di inquinamento).
La tassazione registra problemi di applicazione per diverse motivazioni: occorre valutare l’incertezza sull’equità della tassazione.
Un settore si opporrà sempre all’introduzione di nuove imposte.
Può essere che la tassa andrà oltre la tassazione dell’inquinamento.
C’è inadeguata conoscenza della funzione di danno.
Molti ritengono che sia difficile stimare il danno e che sarebbe possibile trovare altri esperti che proporrebbero stime diverse, lasciando aperta la strada a disputare sul fondamento legale di un’imposta.
Si può sottovalutare il danno ambientale, ma occorre tener conto dei costi marginali di abbattimento.
Le imposte ambientali in Italia fanno riferimento a tre categorie e cioè imposte sull’energia, sui trasporti, e sull’inquinamento, come nei depositi in discariche, tassazione su sostanze gassose o liquide, controllo delle emissioni sonore.
Le imposte ambientali sono imposte di scopo in quanto il gettito viene definito a specifici interventi di protezione ambientale.
La forma più diffusa di controllo dell’inquinamento è la definizione di Standard ambientali, che sono degli interventi per controllare le emissioni e i rifiuti dannosi per l’uomo e per l’ambiente sulla base di norme giuridiche.
– Standard di emissione: si fissa la quantità massima di sversamento per ogni unità di materia in un corpo ricettore
quale l’acqua o l’aria; richiedono un controllo e una penalizzazione in caso di trasgressione.
– Standard sulle qualità di un corpo ricettore: fissano la concentrazione massima di inquinamento totale in un corpo ricettore liquido, lo standard richiede l’abbinamento a una tassa sulle emissioni.
– Standard di processo e di prodotto: riguarda la qualità ambientale dei prodotti e fa riferimento alle nocività che possono aver luogo al momento del consumo (benzina senza piombo, sostanze negli spray dei pesticidi).
Non è agevole l’individuazione dello standard che deve tener conto delle necessità di non determinare eccessi di pressione sul mondo produttivo.
Con la definizione di uno Standard si cerca di fissare dei livelli massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti nell’ambiente (X microgrammi per metro cubo, o un tot di decibel).
Gli Standard vengono fissati in riferimento a criteri sulla salute dell’uomo (non superare tot sostanze inquinanti per mantenere l’acqua potabile, concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione mantenute a livelli tali da non poter danneggiare l’apparato respiratorio).
Solo in modo casuale uno standard determinerà una soluzione economicamente efficiente.
In caso di applicazione di uno standard, l’impresa non ha incentivo a ridurre l’inquinamento oltre quanto stabilito dallo standard poiché non va incontro ad alcuna sanzione qualora lo rispetti.
Può essere desiderabile socialmente incoraggiare gli inquinatori ad investire in tecnologie per ridurre l’inquinamento ad un costo più basso nell’approccio in termini di Standard questo incentivo non esiste, mentre con un’imposta l’inquinatore paga sempre l’imposta e quindi ha un incentivo ad investire in tecnologie che evitino di pagare l’imposta.
I costi amministrativi necessari per definire e gestire un sistema basato sugli Standard ambientali sono alti.
E’ necessario un monitoraggio e deve essere predisposto un sistema di sanzioni per chi trasgredisce lo Standard.
L’onere della ricerca scientifica in campo ambientale è affidato alla pubblica amministrazione (definizione dello standard, monitoraggio, ricerca di soluzioni tecnologiche per ridurre le emissioni inquinanti).
Gli standard sono uno strumento efficace nel caso di danni all’ambiente irreversibili o molto gravi.
Sono accettati dagli ambientalisti per motivi etici, dalle forze politiche per una maggiore familiarità con gli strumenti economici.
Il limite degli standard è che non sollecitano alla messa a punto di una strategia utile ad abbattere l’inquinamento.
I permessi di inquinamento si fondano sul diritto di proprietà all’uso di un bene connesso al teorema di Coase.
Secondo questo approccio la regolamentazione dell’inquinamento potrebbe avvenire direttamente tra inquinatori (titolari di un diritto ad inquinare) e inquinati (titolari di un diritto a non essere inquinati).
Una volta fissato un livello “accettabile” di inquinamento o di qualità ambientale, l’autorità preposta alla regolamentazione distribuisce i permessi di inquinamento negoziabili agli inquinatori, che possono utilizzarli o per inquinare o per venderli sul mercato.
I permessi di inquinamento sono trasferibili.
Nella regolamentazione diretta, il regolatore decide il livello di inquinamento per ogni partecipante, e con i permessi affida al mercato la loro allocazione tra gli inquinatori.
L’autorità di governo ambientale può distribuire gratuitamente i permessi sulla base delle emissioni storiche o può attivare un’asta per distribuirle.
Gli inquinatori con alti costi di abbattimento possono acquistare permessi e inquinare di più di quanto farebbero nella regolazione diretta, mentre quelli con bassi costi di abbattimento trovano conveniente vendere i propri permessi abbattendo le proprie emissioni inquinanti più di quanto farebbero altrimenti.
Rispetto all’imposizione di standard individuali inderogabili, un sistema di permessi trasferibili è vantaggioso sia per gli inquinatori con alti costi di abbattimento sia per quelli con costi bassi.
Gli inquinatori con alti costi di abbattimento trovano conveniente acquistare permessi dal momento che il loro prezzo è inferiore ai costi che dovrebbero sopportare per abbattere autarchicamente le emissioni inquinanti.
Gli inquinatori con bassi costi di abbattimento trovano conveniente cedere permessi ricevendo un corrispettivo superiore al costo che devono sostenere per abbattere le proprie emissioni.
Tre sistemi di permessi:
– il sistema dei permessi basato sui punti ricettori (ambient permit system) APS: utilizza permessi definiti sulla base dell’esposizione in corrispondenza del punto ricettore (punto in cui viene ricevuto l’inquinamento).
Gli Standard di qualità potrebbero variare secondo il punto ricettore: non c’è bisogno che ogni ricettore abbia lo stesso Standard di qualità ambientale.
I permessi devono essere ottenuti sul mercato come permessi nel punto ricettore: lo scambio non avverrà sulla base di uno a uno, ma bisognerà scambiare i permessi sulla base del numero di permessi richiesto per permettere una det concentrazione dell’inquinamento nel punto ricettore.
Ciascun inquinatore può trovarsi di fronte mercati troppo complessi secondo i diversi punti ricettori, e di conseguenza prezzi differenti.
Con l’APS si tiene conto di tutti i punti ricettori.
– il sistema di permessi di emissione (emission permit system) EPS: i permessi vengono emessi sulla base della fonte di emissione, ignorando gli effetti delle emissioni sui punti ricettori.
In una determinata zona l’inquinatore avrebbe un solo mercato in cui trattare ed un unico prezzo, che è il prezzo di un permesso per emettere sostanze inquinanti in quella regione: lo scambio dei permessi è su base di uno a uno, anche l’EPS non evita alcuni problemi in quanto, non discriminando in base ai punti ricettori, è improbabile che riesca a distinguere le fonti sulla base dei danni e risulterà inefficiente.
E’ probabile che ogni area subisca una concentrazione dell’inquinamento in alcune piccole aree specifiche, i punti caldi, dove i livelli di concentrazione superano lo Standard: dato che l’EPS è basato sulle emissioni che avvengono su un’area più vasta, non riuscirà a tenere conto della violazione dello Standard in tutti i punti.
La ridefinizione dell’area per far rientrare il punto caldo in una zona più piccola, alla quale viene poi riapplicato lo Standard, equivale a trasformare l’EPS nell’APS.
L’EPS funziona quindi sulla base di uno scambio uno ad uno in una zona definita, mentre non avviene alcuno scambio al di fuori di quella zona.
Con l’EPS si potrebbero produrre dei danni al di fuori dell’area in questione, che sarebbero ignorati.
– il sistema di controbilanciamento dell’inquinamento (pollution offset system) POS: i permessi vengono definiti in termini di emissioni, lo scambio avviene in un’area definita ma non sulla base di uno a uno; e lo Standard deve essere rispettato in tutti i punti ricettori.
Il valore di scambio dei permessi viene determinato dagli effetti che le sostanze inquinanti esercitano nei punti ricettori.
Il POS combina le caratteristiche dell’EPS (permessi definiti in termini di emissioni e non avviene scambio al di fuori dell’area stabilita), e dell’APS (tasso di scambio dei permessi definito dagli effetti delle emissioni inquinanti sui punti ricettori circostanti).
I vantaggi dei permessi negoziabili sono la minimizzazione dei costi, la possibilità di tener conto di nuovi entranti, le opportunità offerte a chi non inquina, la possibilità di tener conto dei costi di aggiustamento anche con la tecnologia.